Il problema del risarcimento del danno da ritardo nei confronti della P.A. ha sempre determinato dubbi ed incertezze nei quadri dottrinali e giurisprudenziali, al punto che, ancora oggi, sussistono ambiguità sia nella specificazione della natura giuridica di tale responsabilità che nel potere di accertamento e di condanna in materia da parte del giudice amministrativo. Il saggio vuole approfondire tali tematiche nella consapevolezza delle innumerevoli difficoltà argomentative, anche con riferimento ai ritardi negli appalti pubblici
Sommario: 1- Premessa. Il problema del danno da ritardo negli appalti; 2- La natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità della P.A. per danno da ritardo nella giurisprudenza; 3- Le attuali posizioni dottrinali sull’ammissibilità del risarcimento del danno nel caso di mero ritardo; 4-La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di danno da ritardo; 5- Riflessioni conclusive
1- PREMESSA
Com’è noto, la legge n. 69/2009 ha introdotto, nell’originario corpo della legge n. 241/1990, l’art. 2-bis il cui contenuto è assolutamente innovativo, anche se riformula alcuni recenti progetti di legge rimasti tali e avalla alcuni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sedimentati sul regime giuridico della risarcibilità in caso di silenzio-rifiuto. Ai sensi del predetto articolo, infatti, si legge che “1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.” La norma in questione presenta profili di particolare interesse più per quello che non dice che per quello che dice. Il primo punto fermo, dal quale prendere le mosse per comprendere quale rilievo va attribuito alla responsabilità dei soggetti pubblici per inosservanza colpevole del termine di conclusione del procedimento, è costituito dalla estrema lacunosità della disciplina legislativa sulla responsabilità per le violazioni di norma procedimentali.
Il problema deve pertanto essere impostato con riferimento, da un lato, ai principi generali sulla responsabilità civile, e, dall’altro, all’opera della recente giurisprudenza, dedita alla costruzione del c.d. diritto vivente. Le difficoltà peraltro sono enormi. Quanto ai principi, infatti, è difficile dedurre da essi un sistema di regole sicuro e coerente, dato che spesso gli uni indirizzano in un senso che gli altri contraddicono: il principio di responsabilità civile spinge verso soluzioni rigorose, conformate, nel settore pubblicistico, dal riferimento finalistico dell’interesse pubblico che anima le attività amministrative;[1] il diritto vivente della responsabilità pubblicistica, di costruzione giurisprudenziale, cerca di coniugare il profilo codicistico della responsabilità civile (art. 2043 cc. e seg.) con l’evoluzione del danno ingiusto e il risarcimento per lesione dell’interesse legittimo, dando luogo a situazioni spesso contraddittorie al principio di pienezza e di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti.
La giurisprudenza, infatti, nel corso dell’ultimo decennio, ha saputo evolversi profondamente, ma non si è consolidata su posizioni univoche e sedimentate.
La dottrina, dal canto suo, si è dedicata a scandagliare con impegno il tema, ma, com’è ovvio che sia, si è divisa riguardo alle soluzioni da suggerire come le più equilibrate: che non siano cioè inutilmente gravose per le responsabilità delle amministrazioni e rispettino contemporaneamente le esigenze di tutela delle situazioni giuridiche soggettive degli amministrati. In tema di appalto, qualora le parti si limitino a prevedere che il ritardo nella consegna dell’opera non dia titolo ad alcun ‘extra onere’ a carico della ditta appaltatrice senza pattuire la misura dell’indennizzo eventualmente spettante nel caso in cui il ritardo sia superiore, la conseguenza è che il diritto della parte committente rimarrà soggetto all’ordinaria disciplina in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, che subordina l’accoglimento della domanda all’allegazione e prova del pregiudizio sofferto.[2] La responsabilità da ritardo che si modella nella riformulata legge n. 241 del 1990 risiede nella stasi procedurale tra la deliberazione di sospensione della gara e il provvedimento di revoca della stessa non costituisce un contegno violativo del canone di buona fede richiamato dall’art. 1337 c.c. L’inerzia rileva, infatti, non ai fini della responsabilità precontrattuale della P.A., bensì ai fini della diversa forma di responsabilità da ritardo nella conclusione del procedimento.
Le due forme di illecito su appuntano sulla lesione di interessi diversi tra loro: il primo si indirizza al più generale interesse di ordine economico a che sia assicurata la serietà dei contraenti nelle attività preparatorie e prodromiche al perfezionamento del vincolo negoziale; il secondo, invece, si riferisce all’interesse c.d. positivo al tempestivo conseguimento del bene della vita, ossia nella fattispecie alla celere conclusione del contratto, la cui spettanza è, tra l’altro, presupposto indispensabile ai fini della sussistenza del danno ingiusto, sicché alcuna responsabilità è ascrivibile all’Amministrazione ove questa assuma, seppure in ritardo, un legittimo provvedimento sfavorevole.[3] Nel contratto di appalto il ritardo assume una veste peculiare anche nel riconoscimento della voce del lucro cessante ai fini probatori.
Infatti, “Osta al riconoscimento della voce di lucro cessante caratterizzata dalla mancata evasione degli ordinativi di terzi sia il disposto di legge (che, nel disciplinare i termini per la stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione, considerati non perentori dalla giurisprudenza, di fatto non obbliga l’Amministrazione a concludere la gara con la sottoscrizione del contratto e prevede, a fronte di ciò, il solo diritto dell’appaltatore a recedere con rimborso delle spese) che la mancata dimostrazione dell’incidenza delle risorse da tenere a disposizione dell’Amministrazione in vista dell’esecuzione dell’appalto, così che rimane priva di prova la necessaria consequenzialità tra ritardo del provvedimento e perdita delle occasioni di guadagno altrui (essendo i due fatti posti in semplice correlazione temporale, non eziologica, tra di loro).”[4]
2- LA NATURA CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER DANNO DA RITARDO NELLA GIURISPRUDENZA
L’art. 2 bis non fa altro che esplicitare e approfondire quanto poteva già dedursi dall’art. 2043 cc. sulle ipotesi di responsabilità per i danni da ritardo nell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. La “radicale previsione” di una responsabilità speciale della P.A. per omessa decisione nei termini di legge, chiaramente affermata ora dall’ordinamento positivo, costituisce una occasione unica e irripetibile per riflettere nuovamente, in presenza di un tassello di decisiva importanza aggiunto, sulla responsabilità procedimentale della P.A e sulla sua natura giuridica (contrattuale o extracontrattuale), sulla doverosità dell’azione amministrativa, sulla influenza del tempo nella definizione dei procedimenti amministrativi, sul danno da ritardo nella 2 conclusione procedimentale.
La tesi della natura extracontrattuale della responsabilità per il danno da ritardo è la tesi prevalente tanto in dottrina che in giurisprudenza.
L’art. 30 del Codice del Processo amministrativo (D.lgs n. 104/2010 e s.m.i.9 sembra non dare adito a dubbi al riguardo, affermando all’art. 30, comma 4 che “ Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento.
Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.” Con ciò sottolineando che “il danno è meramente eventuale, ovvero non è risarcibile ( ma solo indennizzabile) in re ipsa il mero superamento del termine di conclusione del procedimento ma occorre la prova di un effettivo danno conseguente alla violazione delle norme sulla conclusione del procedimento e che detta prova deve essere fornita dal danneggiato”[5] La situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dal privato che lamenta il ritardo ha natura di interesse legittimo pretensivo, atteso che trattasi di danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento favorevole. La relazione giuridica che si instaura tra privato e l’amministrazione è caratterizzata da due situazioni soggettive entrambe attive, l’interesse legittimo del privato e il potere dell’amministrazione nell’esercizio della sua funzione, finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico (cfr., sulla struttura del rapporto amministrativo.[6] In questo caso, quindi, è configurabile non già un obbligo giuridico in capo all’amministrazione rapportabile a quello che caratterizza le relazioni giuridiche regolate dal diritto privato (da cui scaturirebbe una responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.), ma un potere attribuito dalla legge, che va esercitato in conformità alla stessa e ai canoni di corretto uso del potere individuati dalla giurisprudenza.
In tema di danno da ritardo, la giurisprudenza amministrativa ha consolidato un tradizionale orientamento che aveva , da sempre, qualificato il danno ingiusto in termini di illecito extracontrattuale, con la conseguenza che occorre valutare la condotta del privato, nell’esaminare la domanda di risarcimento, in termini di partecipazione da parte di questo al procedimento amministrativo e di attenuazione della posizione di supremazia dell’amministrazione nell’esercizio della funzione. Il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo di mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi. Infatti, diversamente da quanto avviene nel settore della responsabilità contrattuale, il rapporto amministrativo si caratterizza per l’esercizio unilaterale del potere nell’interesse pubblico, idoneo, se difforme dal paradigma legale, e in presenza di altri elementi costitutivi dell’illecito, a ingenerare la responsabilità aquiliana dell’amministrazione.
Secondo la pronuncia, poiché la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano, è necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c., e non anche il criterio della prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c.
Il riferimento allo schema della responsabilità extracontrattuale comporta anche il richiamo ai principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova, con la conseguenza che – ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale – incombe al ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A., rappresentata dall’attività amministrativa illegittima, che nel caso della fattispecie descritta dall’art. 2 bis, comma 1, L. n. 241 del 1990 è integrato dalla violazione del termine per la conclusione del procedimento; b) l’evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui il privato è titolare; c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.; d) l’elemento soggettivo, nel senso che l’attività illegittima deve essere imputabile all’amministrazione a titolo di dolo o colpa.[7]
Va , infine, sottolineato, per completezza espositiva, che il risarcimento del danno da ritardo o inerzia della P.A. nella conclusione del procedimento postula, ai sensi del comma 1 dell’art. 2-bis, l. n. 241 del 1990, che la condotta inerte o tardiva della P.A. è stata causa di un danno prodottosi nella sfera giuridica del privato il quale, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento stesso. Il danno, del quale il privato deve fornire la prova sia nell’an che nel quantum deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all’adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento da parte della P.A., sempreché non si versi in un’ipotesi di c.d. silenzio significativo. L’ingiustizia e la stessa sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, dovendo l’attore dare la prova, ex art. 2697 c.c., di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in specie, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante): in definitiva, anche se l’art. 2-bis della l. n. 241/1990 rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti della P.A., la domanda va comunque ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità.
La risarcibilità del c.d. danno da mero ritardo, che si configura a prescindere dalla spettanza del bene della vita sotteso alla posizione di interesse legittimo su cui incide il provvedimento tardivamente adottato e si ricollega alla lesione del diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale, vale unicamente quando il soggetto leso dal ritardo della P.A. nell’adozione del provvedimento ha natura imprenditoriale, mentre negli altri casi è indispensabile la prova della spettanza del bene della vita cui si ricollega la posizione di interesse legittimo.[8]
Prima delle novità normative, era stata prospettata la cd. responsabilità da contatto amministrativo qualificato, derivante cioè dalla violazione di obblighi di natura procedimentale imposti alla P.A. dalla legge n. 241/1990 e da altre fonti del diritto, nei confronti del privato.
Si tratterebbe di una tipica responsabilità contrattuale basata sul rapporto giuridico procedimentale e sull’inadempimento della P.A. in relazione ad obblighi procedimentali predeterminati nei confronti del cittadino. La sostanziale assimilazione alla responsabilità contrattuale da parte della responsabilità da contatto amministrativo qualificato era riferita anche al riparto dell’onere probatorio “relativo all’elemento psicologico (non gravante sul danneggiato) e quanto al termine prescrizionale ( decennale e non quinquennale)”.[9] Tale tesi non ha mai avuto riscontro da parte della giurisprudenza, sia per la difficoltà di ravvisare un normale rapporto giuridico di diritto pubblico tra cittadino e amministrazione, sia per il fatto che l’art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 non lascia adito a dubbi, sottolineando la valenza “sanzionatoria” dell’elemento psichico del dolo e della colpa. Oltretutto, la stessa giurisprudenza della Cassazione aveva ribadito che “La responsabilità della Pubblica Amministrazione per atto illegittimo deve essere ricompresa nella previsione dell’art. 2043 c.c., con la conseguente applicazione dei criteri già enunciati nella sentenza n. 500 del 1999 della Corte di Cassazione. Trattandosi di lesione dell’interesse legittimo, il fenomeno non è riconducibile ad una pretesa del cittadino alla regolarità dell’azione amministrativa; conseguentemente il giudice non può applicare i canoni contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1174 e 1175 c.c., neppure alla luce della concezione dei rapporti tra cittadino e amministrazione, introdotta dalla L. n. 241 del 1990.”[10]
3- LE ATTUALI POSIZIONI DOTTRINALI SULL’AMMISSIBILITÀ DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL CASO DI MERO RITARDO
I primi commentatori si contraddistinsero per voci spesso discordanti tra loro, anche se prese piede la tesi a favore della risarcibilità del danno da ritardo mero, “inteso come risarcimento della lesione di un interesse di natura diversa da quella al perseguimento del bene della vita finale”.[11] Secondo alcuni, la responsabilità per danno da ritardo nascerebbe dalla violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza gravante sulla P.A., nel rispetto dei termini procedimentali .[12]
In dottrina si affermarono le tesi fondate sulla doverosità dell’azione amministrativa, intesa come obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in tempi certi. Le norme sulla legge n. 241/1990 che stabiliscono un termine di conclusione del procedimento sarebbero norme di relazione e, quindi, la situazione giuridica dell’istante sarebbe di diritto soggettivo. Si è parlato di responsabilità contrattuale per il risarcimento dei cd. “diritti procedimentali”[13].
Altri hanno addirittura scomodato il rango costituzionale del diritto al rispetto dei tempi del procedimento.[14]
Responsabilità, quindi, da rapporto giuridico, produttivo di diritti soggettivi, pretese sostanziali al provvedimento amministrativo, a prescindere dalle utilità finali di quest’ultimo; certezze svanite per il mero ritardo della P.A.. Si è affermato, semplicemente, che “il danno da vero ritardo” deve essere ritenuto risarcibile, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto, purché la domanda deve riguardare il costo del ritardo, non l’utilità che ci si prometteva dalla decisione richiesta”[15].
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990 molte tesi dottrinali hanno ritenuto di poter cogliere nella norma un’apertura alla tutela risarcitoria del danno da mero ritardo, senza dover articolare nature giuridiche prive di rilevanza pratica sostanziale e processuale.[16]
4-LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI DANNO DA RITARDO
L’art. 133 del c.p.a stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
La disposizione è molto chiara, non si sono dubbi, solo qualche riflessione a supporto. Com’è noto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è stata rivisitata negli ultimi decenni, in virtù di alcuni abusi del legislatore nell’attribuire le controversie della P.A. al giudice ordinario quando la prima non aveva agito nelle sue tipiche vesti di autorità. Ora, il legislatore può attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le materie che, in mancanza di tale previsione, comporterebbero comunque la giurisdizione generale di legittimità, poiché coinvolgono il potere amministrativo.[17]
La giurisprudenza amministrativa nomofilattica successiva ha anch’essa affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma con argomentazioni diverse da quelle della Corte cost. n. 204/2004. Quest’ultima ha stralciato dalla previsione dell’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (nella versione di cui alla legge n. 205 del 2000) il termine «comportamenti», devolvendo al giudice ordinario la cognizione delle liti relative a diritti soggettivi provocate da condotte materiali dell’amministrazione (liti riservate, invece, al giudice amministrativo prima della parziale dichiarazione di incostituzionalità). La giurisdizione esclusiva non va a sindacare i «comportamenti» della pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del neminem laedere (la fattispecie presa in considerazione dal citato art. 34 nella parte dichiarata incostituzionale dalla Corte), ma il mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo della autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative. Si è, perciò, al cospetto di interessi legittimi pretensivi del privato, che ricadono, per loro intrinseca natura, nella giurisdizione del giudice amministrativo (e, trattandosi della materia urbanistico-edilizia, nella sua giurisdizione esclusiva).[18]
In alcune decisioni della Suprema Corte di Cassazione, in realtà il danno da mero ritardo veniva spesso ricondotto alla lesione di un diritto soggettivo, correlato ad un obbligo in capo alla P.A.. Una responsabilità tipicamente contrattuale da inadempimento dovuto a “mero comportamento”, che in mancanza di un’espressa attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, radicava la giurisdizione del giudice ordinario.[19]
Secondo la dottrina, “la scelta fra le possibili nozioni di danno da ritardo è legato ad un problema di giurisdizione, che trova una diversa risposta a seconda che si ritenga che l’amministrazione che ritarda il rilascio del provvedimento tiene, come un comune debitore, un “comportamento” inadempiente lesivo del diritto soggettivo del cittadino interessato oppure incorre in un’inerzia che costituisce una modalità alternativa di esercizio del potere amministrativo “[20].
In dottrina, quindi, la Corte costituzionale è andata più in là: “ ha statuito che materie di giurisdizione esclusiva possono aversi anche se in esse sono configurabili soltanto diritti soggettivi.[21]. e si è riconosciuto il superamento della motivazione originaria per cui la giurisdizione esclusiva era stata istituita nel 1923: ovvero, la complessità delle posizioni giuridiche che rendeva difficile individuare i tratti distintivi delle singole situazioni soggettive di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
5- RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Ma, al di là di questi pur importanti punti di riferimento, a cui si farà cenno per completezza del discorso, mi sembra che una chiave di lettura essenziale per inquadrare sistematicamente la nuova disposizione sia offerta dall’analisi del danno ingiusto da ritardo e dalla tipologia di responsabilità in cui incorrerebbe la P.A. per la violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo. In particolare, la riconsiderazione del mero danno da ritardo appare attuale ed opportuna dato che, non solo negli ultimi tempi, esso ha risentito dei contraccolpi provenienti da normative di fatto rimaste inattuale.
La dottrina amministrativistica non è stata unanime nell’accettazione della figura della responsabilità del danno da ritardo come tutela risarcitoria concettualmente e giuridicamente autonoma e separata da quella di tipo demolitorio offerta dall’annullamento dell’atto amministrativo, anche se non vi erano radicali ragioni ostative ad una normativa che ravvisasse la responsabilità dell’amministrazione per il mero ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.[22] Su tale orientamento si era attestata la giurisprudenza prevalente, anche se con riferimento allo specifico danno da ritardo nell’emanazione del provvedimento cui legittimamente aspirava il soggetto danneggiato e non al danno da mero ritardo. Il convincimento originario, condiviso da dottrina e giurisprudenza, era nel senso di attribuire pieno valore, in caso di interesse pretensivo, al risarcimento del danno da ritardo solo dopo che l’amministrazione avesse esercitato, e in favore del privato leso, il proprio potere.[23]
Un tale atteggiamento era coerente con la disciplina dell’azione amministrativa raffrontata alle recenti elaborazioni e utilizzazioni della figura concettuale dell’interesse legittimo, inteso come interesse strumentale correlato all’interesse al bene della vita ritenuto meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento positivo, ma non in linea con la concezione della P.A. come soggetto giuridico titolare di poteri-doveri nei confronti dei destinatari dell’azione amministrativa e, perciò, responsabile dei fatti d’inadempimento nei confronti di questi. Parte della giurisprudenza, infatti, ha chiarito che non è sufficiente il mero ritardo per configurare il danno ingiusto perché occorre, secondo questa impostazione, la sussistenza di un interesse pretensivo che abbia per oggetto la tutela di interessi sostanziali[24]. In buona sostanza, l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in caso di inerzia dell’amministrazione, presuppone la valutazione circa la spettanza dell’utilità finale da conseguire per il tramite del provvedimento richiesto, mediante un giudizio prognostico che non può essere consentito allorché l’attività dell’amministrazione sia caratterizzata da consistenti margini di discrezionalità amministrativa.[25]
In mancanza di un preciso quadro normativo di riferimento, infatti, la giurisprudenza condiziona il risarcimento del danno da ritardo provvedimentale al positivo accertamento della spettanza all’avente diritto del bene della vita finale sotteso all’interesse legittimo azionato. Il suddetto art. 2 bis, invece, identifica nel fattore tempo il bene della vita la cui violazione legittima la richiesta di risarcimento del danno ingiusto da parte del privato nei confronti della P.A. inadempiente.
Ne deriva che l’amministrazione che provveda in ritardo o che non provveda affatto è tenuta, prescindere da ogni indagine sulla spettanza del bene della vita o dell’utilità finale, a risarcire i danni conseguenti alla situazione di incertezza circa il rilascio o meno del provvedimento richiesto in cui è stato colpevolmente (con dolo o colpa della P.A.) lasciato colui ha presentato l’istanza. [26]Anche se il decorso del termine non fa venir meno il
potere di provvedere, si determina, allo spirare del suddetto termine, la responsabilità civile dell’amministrazione per i danni arrecati dal ritardo. Tale conseguenza è stata messa in luce anche dalla Corte Costituzionale che ha osservato che “l’eventuale inosservanza del termine per la definizione dei procedimenti di pianificazione territoriale in esame, pur non comportando la decadenza dal potere, connoterebbero in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi, al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche attraverso l’utilizzo di tutti i rimedi apprestati dall’ordinamento.
Dal risarcimento del danno al giudizio di ottemperanza”.[27] In definitiva, il dato normativo, avallato da una parte consistente della giurisprudenza, impone la lettura dell’inerzia dell’amministrazione non come esercizio del potere ( o meglio non solo) ma semplice fatto di inadempimento, rispetto al quale non si configura un interesse legittimo ma un vero e proprio diritto soggettivo all’emanazione di un provvedimento e, quindi, all’adempimento amministrativo della prestazione provvedimentale, consistente nel tempestivo esercizio del potere autoritativo attribuito dalla legge alla P.A., in senso favorevole o sfavorevole per il soggetto privato coinvolto. Si comprende, pertanto, come la disposizione in esame qualifichi il dovere di provvedere come la situazione giuridica soggettiva dell’amministrazione che non si contrappone al potere giuridico della stessa ma convive con esso quasi a voler rappresentare un elemento costitutivo dell’esercizio del potere amministrativo. Tale dovere, in questo caso, è una situazione dinamica che vive in una vicenda procedimentale finendo per contribuire a specificarne l’aspetto garantistico in termini di tutela giuridica delle situazioni giuridiche soggettive del cittadino coinvolte nell’azione amministrativa. Inutile dire che dietro questa questione si staglia tutta la complessa tematica dei diritti “procedimentali”, che parte dalla stessa ammissibilità della figura, sino alla definizione delle situazioni giuridiche corrispondenti.[28].
Ritornando sul problema del cd. danno da ritardo, è necessario aggiungere un quid pluris che ne specifichi meglio la cittadinanza nel sistema della responsabilità civile della P.A. Nel continuum dell’evoluzione del concetto di danno ingiusto e sulla sua qualificazione di effettività in termini di riconducibilità ad esso del pregiudizio in concreto patito, occorre ricordare che il fatto illecito è stato individuato nella lesione, perpetrata da una condotta non jure, dei rapporti e delle situazioni organizzati tra il danneggiato e i terzi, cioè dell’attività lecita che il danneggiato avrebbe potuto esercitare se non fosse stata ostacolata o impedita dal fatto illecito. Ciò significa che alla tutela aquiliana, ammessa in tali circostanze, viene riconosciuta soprattutto la funzione di proteggere l’autonomia della “vittima” dai pregiudizi derivanti da fatti dolosi o colposi dell’autore del comportamento illecito. Autonomia che non assurge di per sé a situazione soggettiva meritevole di protezione e avente i connotati del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo, ma autonomia della personalità del danneggiato, quale si estrinseca in fatti o in atti che denotano i presupposti concreti della propria capacità di organizzarsi.
Sotto questo profilo, quindi, per stabilire la risarcibilità effettiva del cd. danno da ritardo derivante dall’inadempimento procedimentale della P.A. non serve solo accertare, da parte del giudice amministrativo, se vi sia stata lesione del diritto soggettivo all’adempimento da parte del destinatario del provvedimento amministrativo ma occorre verificare, soprattutto, se il pregiudizio concreto riguarda beni, rapporti, situazioni di fatto, attività impedite o rese più onerose dall’illecito così perpetrato (perdita subita) e concrete prospettive di sviluppo paralizzate (mancato guadagno).
A sua volta, la determinazione del danno risarcibile “nel suo esatto ammontare”, ovvero anche in via equitativa, consentirà di adoperare criteri obiettivi riferiti alle conseguenze che si verificano nel patrimonio del danneggiato, cioè alle ripercussioni sull’attività del privato leso nei suoi rapporti con i terzi. Il danno ingiusto da ritardo consiste, dunque, non nella mera lesione di un diritto o pregiudizio ad un bene, bensì nelle conseguenze patrimoniali che si sono verificate nella sfera giuridica patrimoniale del cittadino leso, titolare del diritto soggettivo al provvedimento, in conseguenza del ritardo colpevole dell’amministrazione nel provvedere. La ricorrenza del danno da ritardo risarcibile postula perciò un’indagine ulteriore sul suo effettivo verificarsi, che investe il rapporto di causalità tra il danno-evento (mero ritardo) e il danno conseguenza ( conseguenze patrimoniali e di carattere economico). Ne deriva che la risarcibilità del danno investe anche il pregiudizio arrecato ai rapporti giuridici e alle situazioni relazionali in cui il privato richiedente il provvedimento opera: è qui che si verifica il danno, in quanto si traduce nella perdita ,o nella maggiore difficoltà di mantenere o di continuare la programmazione concreta del proprio sviluppo in sé considerato ( si pensi al silenzio operato dal comune su una richiesta di un permesso di costruire che, se perpetrata nel tempo, riduce il valore edificatorio del terreno) o che deriva dagli accordi pregressi con i terzi.[29] ( rapporti economici del richiedente imprenditore con altri imprenditori terzi, interessati indirettamente all’emanazione del provvedimento amministrativo dovuto).
E veniamo ora, per brevi cenni, ad alcuni importanti corollari di questa impostazione.
Il primo concerne il problema della natura giuridica della responsabilità dell’amministrazione per mancata conclusione del procedimento amministrativo. Il secondo riguarda la riconducibilità della stessa tipologia di responsabilità alla P.A. come apparato, secondo quanto deriva dal contenuto dispositivo di cui al citato art. 2 bis. Sotto il primo aspetto, la violazione del dovere procedimentale di provvedere sembrerebbe richiamare la responsabilità di tipo contrattuale della P.A., attesa la natura negoziale, secondo parte della dottrina, del contatto amministrativo qualificato tra P.A. e privato destinatario del provvedimento.9[30]
Il distacco dal passato è radicale: dall’immunità sostanziale nell’esercizio del potere, la p.a. si vede sottoposta all’adempimento di un dovere che la responsabilizza rispetto a chiunque entri, anche senza poter vantare alcun affidamento, nelle maglie del procedimento amministrativo.1[31] Si è parlato al riguardo di violazione dei doveri di correttezza della p.a. nei confronti del cittadino, ma questa non è l’unica prospettiva possibile, perché la lesione inferta alla sfera giuridica del cittadino può riguardare anche l’aspettativa di un provvedimento favorevole. E, almeno ipoteticamente, la lesione di tale diversa aspettativa potrebbe dar vita ad una responsabilità di tipo aquiliano e non contrattuale, rispetto alla quale varrebbero regole e principi diversi.[32]
Al riguardo, non si vuole completamente negare che alla responsabilità della p.a. per violazione dell’obbligo di provvedere possa riconoscersi natura contrattuale (ricostruzione interessante che presuppone l’assimilazione del rapporto giuridico procedimentale al vincolo negoziale, con tutte le logiche conseguenze riconducibili ai principi e ai criteri del codice civile), ma si vuole affermare che tale responsabilità della p.a. non è integralmente traducibile solo nell’inadempimento procedimentale perché presuppone a monte un illegittimo esercizio del potere autoritativo, di cui il dovere di adempimento provvedimentale costituisce l’elemento costitutivo e l’aspetto fondamentale della responsabilità stessa. In altri termini, affermare in questo caso la responsabilità contrattuale della p.a. significa impossibilità di operare una qualunque selezione fra gli interessi lesi: qualunque tipo di vizio, di forma o di sostanza, rispetto a qualunque tipo di interesse dovrebbe condurre all’esito risarcitorio, posto il solo inadempimento della prestazione dovuta dalla p.a.
Anche colui che senza poter vantare alcun affidamento verso un risultato che, magari con certezza non gli spetta, potrebbe pretendere un risarcimento del danno, lamentando qualunque profilo di illegittimità della condotta della p.a.[33]
La conclusione, dunque, è che la responsabilità della p.a. deve restare di natura aquiliana e che proprio l’ingiustizia del danno consente di operare una congrua selezione degli interessi meritevoli di tutela e, quindi, risarcibili ( come quello derivante dal mero ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo). Tutto ciò anche al fine di evitare di complicare ulteriormente il sistema con figure ibride di responsabilità, a metà tra quella contrattuale ed extracontrattuale, con l’esito di creare difficoltà ai giudici nel disporre il riparto dell’onere probatorio secondo criteri uguali o diversi da quelli codificati dall’art. 1218 cc.[34]
Il secondo aspetto, cui si è fatto cenno, è collegato funzionalmente al primo e riguarda l’analisi della fattispecie di responsabilità della p.a. come apparato per i danni ingiusti derivanti dal ritardo nel provvedere. E cioè, il problema dell’inefficienza procedimentale come causa principale e a monte del mero ritardo provvedimentale. Secondo parte della dottrina, “la progressiva dequotazione degli elementi soggettivi dell’azione amministrativa, e la sua sempre più ampia funzionalizzazione conseguente allo sviluppo del procedimento amministrativo, hanno condotto all’offuscamento prima ed all’obsolescenza poi della distinzione materiale tra atto e comportamento, mettendo in crisi la stessa traducibilità dell’azione amministrativa nei termini propri dell’atto giuridico, e determinando la tendenziale confluenza delle forme giuridiche di tale azione all’interno di una nozione ampia ed omnicomprensiva di comportamento, giuridicamente apprezzabile nella sua dimensione oggettiva”[35].
Secondo tale autore, e l’opinione è pienamente condivisibile, se l’enucleazione del concetto di atto giuridico all’interno della condotta umana giuridicamente rilevante deriva dalla importanza degli elementi subiettivi e psicologici dell’azione considerata, non sembra contemplabile nei termini propri dell’atto una manifestazione comportamentale strutturalmente composita e di valore oggettivo, quale quella in cui si traduce l’esercizio della funzione amministrativa. Si comprende, pertanto, come mai sia avvenuto che, proprio in seguito alla legge sul procedimento, e nell’ottica dell’attuazione dei principi sostanziali sottesi al buon andamento amministrativo (soprattutto efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa), dottrina e giurisprudenza si siano poste (con maggior lena che non nel passato) il problema del rilievo da attribuire all’illegittimtà del silenzio dell’amministrazione, non inteso, quest’ultimo, quale semplice risvolto del rapporto di contrarietà del comportamento omissivo finale rispetto al diritto obiettivo, ma come qualificazione giuridica che inerisce anch’essa fondamentalmente e globalmente alla condotta posta in essere dell’autorità amministrativa dell’esercizio del potere.
E’ così la stessa articolazione interna dell’azione amministrativa che si presenta quale indifferenziato continuum comportamentale che dà vita all’idea della nascita di un nucleo comportamentale privilegiato di azione amministrativa che esalta la funzione decisionale del provvedimento. In altre parole, il contenuto sostanziale della decisione finale racchiude tutti gli elementi comportamentali decisivi e preparatori dello stesso provvedimento finale rendendo “responsabile” del possibile ritardo nell’emanazione del provvedimento l’intero apparato amministrativo.
In un tale ordine di idee, la responsabilità dei diversi momenti in cui si dipana l’azione amministrativa, oltre a rendere responsabili i diversi soggetti fisici per i singoli atti amministrativi, fonda il valore forte della soggettività dell’amministrazione tenuta al rispetto dei principi sostanziali dell’attività amministrativa: buon andamento ed imparzialità. A tali profili pare dunque plausibilmente riconnettersi la responsabilità della p.a. come apparato, le cui disfunzioni sono idonee a fondare la responsabilità per il fatto illecito dell’inadempimento ex art. 2 bis della legge n. 241 del 1990. L’incedere di forme di illiceità della “Società del rischio” (Risikogesellschaft), espressive della tendenza alla “modernizzazione” del diritto amministrativo, in cui gli illeciti si muovono in direzione della tutela di beni giuridici sovraindividuali ( buon andamento ed imparzialità amministrativa). Primeggiano, in queste costellazioni, modalità di aggressione “complesse”, dove la fisionomia individuale del binomio funzionario-cittadino viene spesso sostituita da una relazione che vede collocati, dal lato del soggetto attivo, mega-apparati amministrativi (le organizzazioni complesse) e, dal lato del soggetto passivo, i destinatari dell’azione amministrativa. Ciò che rileva è la cd. “dominante collettiva” : l’ingiustizia del danno da mero ritardo, nell’ottica del diritto positivo, si fonda, cioè, sull’assunzione di decisioni finali, che costituiscono l’epilogo di procedimenti scanditi da una molteplicità di fasi che, a loro volta, prevedono l’intervento di una pluralità di soggetti.
Nei mega-apparati ciascuna fase vede all’opera una pluralità di soggetti che operano in vista del provvedimento finale ( sia esso accordo amministrativo o provvedimento amministrativo in senso stretto), espressione della volontà dell’ente. L’antitesi che si profila non è più tra la realizzazione monosoggettiva, fondata sul modelli individualistico di azione che esprime il dominio del funzionario sul comportamento amministrativo; al contrario, nelle pubbliche amministrazioni, la responsabilità diventa spesso di natura collettiva e vede contrapposte la responsabilità plurisoggettiva delle persone fisiche, basata su un modello iperfrazionato di azione, e la responsabilità diretta dell’organizzazione amministrativa complessa, alla quale la cd. “ decisione collegiale” è da riferire sul piano dell’interesse o del vantaggio. Sotto questo profilo, sembra ormai codificata, negli usi linguistici dei giuspubblicisti, l’espressione “responsabilità della p.a. da cattiva organizzazione che attiene, come chiaramente allude l’aggettivazione, ai danni e alle conseguenze ad essi connesse, che occorrono nell’organizzazione dell’attività amministrativa. Il dovere dell’ente di assicurare il rispetto delle leggi amministrative, può continuare a fare in ultima analisi affidamento nella capacità e nella correttezza dei soggetti ritenuti idonei all’espletamento delle funzioni amministrative apicali. Ovviamente, ricadranno sull’ente le conseguenze di un affidamento mal risposto, non diversamente da come ricadrebbero sull’ente le conseguenze dei difetti di struttura o di funzionamento di un qualsiasi modello organizzativo. In altre parole, i modelli di buona organizzazione dell’ente sono funzionali al corretto adempimento dei doveri legalmente sanzionati dei soggetti apicali e alla prevenzione di illeciti da parte loro.
Ma, ed è questa la novità della riforma che si commenta, la colpevolezza dell’ente non viene identificata tout court con la colpevolezza dei funzionari responsabili dei danni da mero ritardo, ma starebbe in ultima analisi in un deficit dell’organizzazione o dell’attività, rispetto ad un modello di diligenza esigibile dalla persona giuridica nel suo insieme. Queste situazioni, lungi dall’essere oggetto di mere annotazioni esterne e ai margini del fenomeno indagato, non sono di poco momento: allude ad almeno due valutazioni operate dagli interpreti.
a) La prima è se i danni derivanti da carenza di organizzazione meritano una menzione a sé, probabilmente perché con l’esercizio dell’attività amministrativa si moltiplicano le occasioni di danno, in ciò confermandosi quella linea evolutiva che contrassegna la stagione attuale della responsabilità civile.
b) La seconda è se la responsabilità della p.a. per disfunzioni amministrative ha caratteristiche peculiari, che ne consigliano una trattazione (e quindi una denominazione) autonoma.
Ma si potrebbe fare anche un’ulteriore annotazione: in materia di responsabilità civile le partizioni interne riguardano generalmente le modalità in cui il danno si verifica, riguardando ora il danno provocato da edifici, ora da attività pericolosa. Anche questa è una circostanza che indica una progressiva oggettivazione delle tecniche di analisi delle responsabilità, spostando l’attenzione dal soggetto danneggiante, alle modalità dell’illecito e quindi al tipo di danno cagionato. Ragione di più per esaminare le questioni di carattere generale che investono la responsabilità della p.a. per difetto di organizzazione procedimentale. Riguardo a questo tipo di responsabilità della p.a. si è in presenza di danni cagionati nell’esercizio di una funzione pubblica e derivanti, nella fattispecie di cui all’art. 2 bis, dalla mancata adozione nei termini stabiliti del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.
Tale anomalia è pur sempre riconducibile all’organizzazione in quanto tale, ravvisabile in quelle situazioni in cui la p.a. agente dimentica di essere una struttura pubblica complessa e qualificata per agire, secondo i principi di legalità, imparzialità e buon andamento, per il conseguimento di determinati obiettivi secondo programmi prefissati, in violazione della stessa clausola generale di correttezza o, addirittura, di affidamenti ingenerati nel cittadino con l’attività procedimentale precedente alla mancata assunzione dovuta di provvedimenti produttiva di danni ingiusti al cittadino. Poste tali premesse, al quesito sub a al quesito si può allora rispondere riassuntivamente affermando che in materia di attività procedimentale e di comportamenti amministrativi non si applicano norme specifiche o principi diversi da quelli costituzionali (art. 97 Cost.) e dalle legge generale sul procedimento amministrativo, integrata dalle leggi di settore. E allora sembra utile rispondere in modo negativo anche alla seconda questione, indicata sub b). Parlare di un diritto speciale della responsabilità civile dello Stato, per ora, significa alimentare equivoci e dubbi; un criterio unificante potrebbe essere quello di ampliare le categorie dell’attività amministrativa ed introdurre diverse coperture assicurative, a seconda della peculiarità dell’attività amministrativa considerata, per proteggere il cittadino coinvolto nell’azione amministrativa da rischi connessi all’azione amministrativa stessa.
Ma senza l’intervento del legislatore in materia, la vedo difficile. Meglio parlare, quindi, di responsabilità diretta della pubblica amministrazione per fatto illecito proprio, lesivo del diritto soggettivo del cittadino al provvedimento amministrativo espresso, dove si ha riguardo non al finale momento in cui, per mancanza di provvedimento,il danno è stato cagionato, bensì alla antecedente fase nella quale la p.a., intesa come “apparato”, si è organizzata, nel rispetto delle regole cui i pubblici uffici debbono conformarsi a norma dell’art. 97 Cost., per dare corso al procedimento rispetto al quale il “non” provvedimento è il solo riepilogo. Il dolo e la colpa della p.a., di cui fa menzione il citato art. 2 bis , vanno riferiti alla mancata adozione di quelli che il d.p.r. n. 231 del 2001 definisce come “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire gli illeciti e, in definitiva, delle misure idonee ad evitare il danno di cui all’art. 2050 cc.
Per facilitare la prova al cittadino danneggiato, non si potrà pretendere che sia proprio il cittadino leso a dare la prova della cattiva organizzazione del pubblico uffici.
Nello spirito della riforma di cui all’art. 2 bis sarà più corretto ritenere che incombe sulla pubblica amministrazione, per sottrarsi alla responsabilità, l’onere di provare che il lesivo comportamento del funzionario agente non le è imputabile, avendo essa adottato modelli di organizzazione degli uffici e di gestione del procedimento amministrativo conformi alle regole di proporzionalità, affidamento, ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità, idonei a prevenire eventi di danno. Addossare l’onere della prova al soggetto che si trova nella migliore condizione per assolverlo è prassi costantemente seguita dalla giurisprudenza. [36]Così, l’illegittimità della mancata conclusione del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso determina una presunzione di colpa della p.a.,ma non una presunzione assoluta, come pure talvolta si è ritenuto, bensì solo relativa, vincibile con la prova contraria, da parte dell’amministrazione, che l’illegittimità denunziata non le è imputabile, avendo essa adottato, nei regolamenti di organizzazione dei pubblici uffici, modelli di comportamento conformi ai precetti costituzionale di cui agli artt. 97 e 98 Cost. In definitiva si può seguire con piena condivisione lo sforzo della giurisprudenza di fornire soluzioni concrete equilibrate al problema della rilevanza della responsabilità di “apparato” della p.a.; mentre qualche preoccupazione desta l’intervento del legislatore, soprattutto ai fini operativi e per l’incidenza notevole che la questione avrà sulla capienza delle casse dello Stato a causa dei risarcimenti dovuti.
Da sottolineare, comunque, come auspicio per il futuro in altri settori del diritto amministrativo, la presa di coscienza del legislatore dell’opportunità di predisporre forme di tutela del cittadino danneggiato dagli illeciti dell’amministrazione per le disfunzioni amministrative procedimentali.
Forme di protezione, queste, idonee a superare la staticità degli strumenti e dei concetti propri del sistema tradizionale della responsabilità civile attraverso un nuovo concetto di colpa di apparato e una riformulazione della cd. responsabilità autonoma dei soggetti di diritto pubblico per la mancata predisposizione di adeguati strumenti di amministrazione e di gestione, tendenti ad eliminare i danni ingiusti derivanti dalla mancata conclusione dei procedimenti amministrativi.
____________________
[1] Più ampiamente, mi si consenta di rinviare a SORICELLI, La codificazione della disciplina speciale della responsabilità della P.A. per danno da ritardo? in https://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3512.pdf
[2] Trib. Trieste, sez. I, 25 agosto 2022, n. 435 in Redazione Giuffrè 2022
[3] T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 29 settembre 2022, n.45 in Foro amm. (Il) 2022, 9, II, 1121
[4] T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02 maggio 2023, n.7365 in Foro amm. (Il) 2023, 5, II, 777
[5] MADDALENA, Art. 2 bis “Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento. Il danno da ritardo: profili sostanziali e processuali in Alberto Romano, L’azione amministrativa, Torino Giappichelli, 2016, 178
[6] Cons. Stato (Ad. Plen.), 23 aprile 2021, n. 7 in Danno e Resp., 2021, 4, 509 nota di VISCONTI il quale sostiene che, a conforto della tesi extracontrattuale della responsabilità della P.A. da ritardo colposo o doloso, che “La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 cod. civ. – da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento – i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’art. 1225 cod. civ. (Afferma i principi di diritto.) Ad affermarlo è l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Il caso esaminato riguardava il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.”
[7] Cons.st., sez. V, 13 settembre 2023, n.8299 in Resp. civ. prev. 2023, 5, 1688.
[8] Tar Lecce (Puglia), 3 gennaio 2024 in Foro amm 2024, 1, II, 105; Cons st., Ad.Plen. 4 maggio 2018, n.5 in
lamministrativista.it 18 GIUGNO 2018 (nota di: Martinelli Marco, De Rose Raffaella), “Affinché nasca la responsabilità dell’amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all’amministrazione”.[9] MADDALENA, Art. 2 bis “Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento. Il danno da ritardo: profili sostanziali e processuali in Alberto Romano, L’azione amministrativa, cit., 179
[10] Cass, sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157 in Foro it., 2003, I, 78, con nota di F.FRACCHIA
[11] MADDALENA, Art. 2 bis “Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento. Il danno da ritardo: profili sostanziali e processuali in Alberto Romano, L’azione amministrativa, cit., 188
[12] CLARICH, Termine del procedimento e potere amministrativo, Torino, 1995, 149
[13] RENNA, Obblighi procedimentali e responsabilità della amministrazione in Dir.amm., 2005, 567
[14] MICARI, Provvedimento amministrativo negativo tardivo: l’adunanza plenaria del danno da ritardo “mero” infittisce la rete di contenimento, in Giust.civ., 6/2006, 1329 ss; CIOFFI, Dovere di provvedere e pubblica amministrazione, Milano, 2005; CLARICH-FONDERICO, La risarcibilità del danno da mero ritardo dell’azione amministrativa, in Urb. e app., 2006, 62; PASTORI, Attività amministrativa e tutela giurisdizionale nella legge 241/90 riformata, in L.R. PERFETTI ( a cura di), Le riforme della l. 7 agosto 1990 n. 241 tra garanzia della legalità e amministrazione di risultato, Padova , 2008, 3 ss; PROTTO, Responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi: alla ricerca del bene perduto, in Urb e app., 2000, 1005 ss
[15] PATRONI GRIFFI, La responsabilità dell’amministrazione: danno da ritardo e class action. in www.federalismi.it, n.2/ 2009, 1 ss; D. RUSSO, La nuova disciplina dei termini e della responsabilità per danno da ritardo, in R. GAROFOLI (a cura di), La nuova disciplina del procedimento e del processo amministrativo, Roma, 2009, 22; MADDALENA, Art. 2 bis “Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento. Il danno da ritardo: profili sostanziali e processuali in Alberto Romano, L’azione amministrativa, cit., 189-190
[16] Tra gli autori che hanno affrontato il tema della responsabilità della P.A. per danno da ritardo, si ricordano, CAVALLARO, Brevi considerazioni sul danno da ritardo della pubblica amministrazione, in Foro amm.T.a.r. 2005, 489; COMPORTI, La tutela risarcitoria della certezza giuridica sulle facoltà inerenti al diritto dominicale assoggettato al potere pianificatorio della pubblica amministrazione, in Giust. Civ., 2004, I, 981; TOSCHEI, Obiettivo tempestività e certezza dell’azione, in Guida al diritto, 2009, fasc. 27, 29; SORICELLI, Il tempo quale bene della vita nel procedimento amministrativo e il danno da ritardo: un falso problema?in Gazzetta Amministrativa n. 1/2017, 1-16; GISONDI, Il legislatore consacra la risarcibilità del danno da ritardo, in F. CARINGELLA – M. PROTTO, Il nuovo procedimento amministrativo, Roma, 2009, 146; POLICE, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio inadempimento, in M.A. SANDULLI, Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2011, 226 e ss., 228; VACCA, Risarcimento del danno da perdita di chance: ontologia di una fattispecie dalle connotazioni sfuggenti in www.lexitalia.it, n.9/2005, 1 ss; D’ANCONA, Il termine di conclusione del procedimento amministrativo nell’ordinamento italiano. Riflessioni alla luce delle novità introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n .69, in www. giustamm.it, 2009; TORIELLO, Le nuove regole del tempo amministrativo, in . CARINGELLA – M. PROTTO, Il nuovo procedimento amministrativo, cit., 76; GIOVAGNOLI, I silenzi della pubblica amministrazione dopo la legge n. 80/2005, Milano, 2005, 205 ss
[17] Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204, in Foro amm – C.d.S. (Il) 2004, 1895,2475 (nota di: SATTA; GALLO; SICLARI)
[18] Cons.st ad. plen., 15 settembre 2005, n.7 in Appalti Urbanistica Edilizia 2006, 6, 350 osservazione (s.m.)(osservazione di: N.D.D.). Stando così le cose, può affermarsi che il sistema di tutela degli interessi pretensivi – nelle ipotesi in cui si fa affidamento (come nella specie) sulle statuizioni del giudice per la loro realizzazione – consente il passaggio a riparazioni per equivalente solo quando l’interesse pretensivo, incapace di trovare realizzazione con l’atto, in congiunzione con l’interesse pubblico, assuma a suo oggetto la tutela di interessi sostanziali e, perciò, la mancata emanazione o il ritardo nella emanazione di un provvedimento vantaggioso per l’interessato (suscettibile di appagare un “bene della vita”). Per la dottrina, si vedano QUINTO, Il Codice del processo amministrativo ed il danno da ritardo: la certezza del tempo e l’incertezza del legislatore, in www. giustamm.it, 2009: FALCON, Il giudice amministrativo tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di spettanza in Dir.proc.amm., 2001, 317
[19] Cass. civ. Sez. Unite Ord., 30 ottobre 2008, n. 26023 in Mass. Giur. It., 2008
[20] FARES, Meri comportamenti e riparto di giurisdizione: il contributo delle Sezioni Unite sul danno da ritardo, in Foro amm., C.d.S., 2010. 5, 987; F.G. SCOCA, Osservazioni eccentriche, forse stravaganti, sul processo amministrativo in Dir. proc. amm., 3/2015, 847 ss
[21] Corte cost., 19 ottobre 2009, n. 259 in Giur. cost. 2009, 5, 3601 NOTA (s.m.) (nota di: SCOCA; LEHNER)
Corte cost. 5 febbraio 2010, n. 35 in Giur. cost. 2010, 1, 432 NOTA (s.m.) (nota di: SCOCA;CROCE) Premesso che la giurisprudenza della Corte ha chiaramente definito i confini della g.a. esclusiva, esigendo, ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al g.a. la cognizione non di “blocchi di materie”, ma di materie determinate; e che l’amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio”
[22] 1 In un quadro non dissimile si muoveva, d’altra parte,-secondo talune linee interpretative- l’art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 59 del 1997, che ipotizzava “forme di indennizzo automatico e forfettario”, pur se a favore del richiedente, qualora l’amministrazione non avesse adottato tempestivamente il provvedimento, anche se negativo. Tale disciplina non è stata attuata e non sono state predisposte iniziative per l’emanazione di una nuova legge di delega con lo stesso contenuto o per la proroga del termine sia per motivi di resistenza politico-amministrativa che per difficoltà operative pratiche dovute alla notevole incidenza negativa degli indennizzi sui bilanci pubblici.
[23] Cons.Stato, sez. VI, 11 dicembre 2006, n. 7215 , in Foro Amm. CDS, 2006,12, 3382
[24] Cons.Stato, sez. IV, 26 maggio 2006,n. 3201, in Foro Amm.CDS, 206, 5, 1430
[25] Cons.Stato, sez IV, 29 gennaio 2008, n. 248, in Guida al Diritto, 2008, 10,95
[26] LIBERATI, La responsabilità della pubblica amministrazione ed il risarcimento del danno, Volume II, Padova 2009, 498 e ss. Sul danno da ritardo, notevoli sono i contributi dedicati, tra cui GASPARI, Danno da ritardo e pa: criticità e profili evolutivi, articolo del 10.04.2008 in www.altalex.com. n. 2559 del 16.07.2009 ,1 e ss, la quale afferma, riprendendo gli orientamenti maggioritari di dottrina e di giurisprudenza sull’argomento, che il danno da ritardo, quale lesione di un interesse legittimo pretensivo è un sintagma ovvero un’entità di sintesi in cui sono inglobati il diritto ad una prestazione (la tempestiva conclusione del procedimento amministrativo) e l’interesse al bene della vita che l’esecuzione della prestazione soddisfa (il rilascio del provvedimento).
[27] Corte Cost. sent. n. 176/2004 in www.giurcost.org/decisioni/2004/0176.
[28] Sul punto MORBIDELLI, Il tempo del procedimento in AA.VV. La disciplina dell’azione amministrativa a cura di Vincenzo Cerulli Irelli, Napoli, 2006, pp. 250-264; S.S.SCOCA, Il termine come garanzia nel procedimento amministrativo, in Giustizia amministrativa. Rivista di diritto pubblico on line (www.giustamm.it), 2005. Sull’obbligo di provvedere e sulla doverosità dell’azione amministrativa, F.G. SCOCA, Il silenzio della pubblica amministrazione, Milano, 1971; ID., Le situazioni giuridiche soggettive-nozioni generali- in AA.VV. Diritto amministrativo a cura di Franco Gaetano Scoca, Torino, 2008, pp. 136-137; LEDDA, Il rifiuto di provvedimento amministrativo, Torino, 1964; ZITO, Il procedimento amministrativo in AA.VV. Diritto amministrativo,cit., 215-242; CIOFFI, Dovere di provvedere e pubblica amministrazione, Milano, 2005; GOGGIAMANI, La doverosità della pubblica amministrazione, Torino, 2005
[29] Sul tema dei rapporti tra procedimento amministrativo, nesso di causalità tra fatto illecito e danno patito e sulla necessità di individuare i terzi legittimati al completarsi del procedimento e la loro tutela, COSTANTINO, Illecito civile ad enti pubblici territoriali in AA.VV., Responsabilità civile e tutela dei diritti, V., Studi in onore di Pietro Rescigno, Milano, 1998, 184-187
[30] Dopo la famosa sentenza n. 500 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, l’obiettivo dei teorici è quello di enfatizzare il rovesciamento radicale nei rapporti tra P.A. e privati, dovuto in primis, dovuto in primis alla legge sulla riforma del procedimento amministrativo 241/1990, che conduce sino alla proposta di sostituire alla relazione tra esercizio di un potere pubblico ed interessi legittimi, un rapporto di obbligazione della p.a. nei confronti dei privati . Così AGRIFOGLIO, Le sezioni unite tra vecchio e nuovo diritto pubblico: dall’interesse legittimo alle obbligazioni senza prestazione in Europa e diritto privato, 1999, 1241 e ss; CASTRONOVO, Responsabilità civile per la p.a. in Jus, 1998, 661 ss. Anche parte della giurisprudenza si è attestata sulla natura contrattuale dell’illecito commesso dalla p.a., pur nelle difficoltà insite nella natura ibrida di tale responsabilità pubblica. Su tutte (Trib. Roma, 30 giugno 2003, in Giur merito, 2003, 2269 e ss)
[31] NAVARRETTA, L’ingiustizia del danno e i problemi di confine tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale in AA.VV. Attuazione tutela dei diritti, volume IV, III, La responsabilità e il danno, Milano, 2009, 243.
[32] .ROMANO TASSONE, La responsabilità della p.a. tra provvedimento e comportamento ( a proposito di un libro recente) in Dir.amm.2/2004, 225.
[33] NAVARRETTA, Op.ult. cit., 245
[34] Il discorso è reso complesso anche dalla non agevole possibilità di distinguere tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso il venir meno delle differenze fondamentali tra le due tipologie per la considerazione che oggi l’obbligazione contrattuale tende a considerarsi come struttura complessa e pertanto essa involge obblighi accessori; nel contempo la responsabilità civile tende a coinvolgere sempre di più fenomeni negoziali (es. doppia vendita immobiliare) e, nel procedimento amministrativo, il rapporto procedimentale tra p.a. e privati. Non a caso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana , ord., 8 maggio 2002, n. 267, in Corr. Giur.,2002, 880 ss, con nota di Carbone), nel rimettere all’adunanza plenaria il problema della natura della responsabilità della p.a., ha evidenziato l’impossibilità di operare una selezione fra le norme sulla responsabilità, mettendo in risalto le possibili conseguenze operative di una tale scelta sul piano dei danni risarcibili, del computo degli interessi e della rivalutazione nonché della prescrizione dell’azione.
[35] ROMANO TASSONE, Op. ult. cit., 222
[36] Cass. 12 marzo 2002, n. 3573, in Mass. Foro it., 2002; Pret. Taranto, 22 maggio 1986, in Arch. Circolaz., 1987, 972; Cass. 13 aprile 2007, n. 8826, in Mass. Foro it.,2007; DE MATTEIS, Responsabilità e servizi sanitari, in Trattato di diritto commerciale dir. Pubbl.. dell’economia, Padova, 2007, 355 ss; Ampiamente in argomento, GALGANO, Trattato di diritto civile, volume secondo, Padova 2009, spec. 972 ss e, specificamente, sulla responsabilità da inefficienze delle strutture sanitarie, BREDA, Il risarcimento dei danni da inefficienze della struttura sanitaria, in AA.VV. La responsabilità civile, tredici variazioni sul tema, a cura di Giulio Ponzanelli, Padova, 2002, 295 ss; PULITANO’, Voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche in Enc.dir. Agg., VI, Milano, 2002, 953 ss.
- Canali tematici
- Contenuti
- Channel
- Il Quotidiano
- Massimario
- Codice appalti commentato
- Prodotti Maggioli















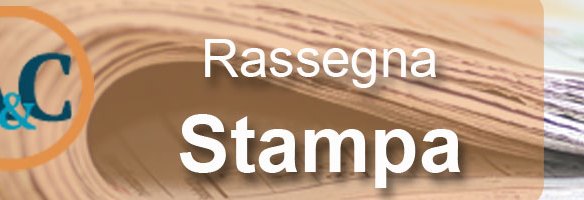
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento