1. Premessa. L’importanza della tecnica
Il nuovo codice dei contratti pubblici condensa in norme gli interessi pubblici prevalenti in un dato contesto e tempo. Molte leggi, però, per la loro complessità non possono semplicemente contare su un’autonoma esecuzione da parte dei consociati, ma abbisognano di apparati “tecnici” che le attuino, traducendo la norma in operatività pratica.
Una di queste leggi, sia pure connotata di spiccata elasticità, è certamente il d.lgs. n. 36 del 2023, ossia il citato nuovo codice dei contratti pubblici, che anche nei suoi correttivi imminenti, dimostra come siano mutati i rapporti di forza fra i tipici istituti dei contratti pubblici, dal partenariato pubblico-privato ai poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla digitalizzazione di origine PNRR. Di conseguenza, si sono trasformate le soluzioni istituzionali per il potenziamento e il coordinamento delle funzioni amministrative.
Il collegio consultivo tecnico, annoverato tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici sin dal d.l. 16 giugno 2020, n. 761 sembra ricevere nella disciplina dettata dagli artt. 215 al 219 del d.lgs. n. 36 del 2023 (c.d. nuovo codice dei contratti pubblici), una nuova mission: da luogo di scambio di conoscenze e di expertise con i diversi organismi operativi nei contratti pubblici si erge a struttura tecnica di risoluzione delle controversie alternativa alla tutela giurisdizionale. I principi tecnici assumono particolare importanza nelle disposizioni richiamate poiché rappresentano la costruzione concettuale di esigenze dettate dall’opportunità pratica o dalle politiche pubbliche e la loro configurazione deve essere giustificata pur sempre nell’ambito del diritto2.
Negli ultimi tempi, la dottrina amministrativistica si è confrontata inevitabilmente con l’apertura e la disponibilità a considerare impostazioni elaborate dalla tecnica, considerata l’immanente indeterminatezza delle norme “tecniche” dell’azione amministrativa. Da sempre, la tecnica “opera in funzione di limite alla discrezionalità politico-amministrativa, assicurando una maggiore impermeabilità delle scelte rispetto alle contingenze della politica”3.
Il dialogo tra tecnica e diritto può rappresentare un fattore di legittimazione delle decisioni amministrative proprio in virtù di quel continuo adattamento, aggiornamento e rinnovamento delle decisioni amministrative alla “potenza” della tecnica4. La giurisprudenza costituzionale ha spesso valorizzato gli interessanti profili della compenetrazione tra diritto e tecnica, dando fiducia a quest’ultima nell’ottica della predeterminazione ed oggettivazione delle scelte amministrative discrezionali attuative dei principi di buona amministrazione5.
La sentenza della Corte costituzionale6 pone particolare enfasi al fatto che “l’individuazione del termine di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e guariti, ovverosia dell’arco di tempo nell’ambito del quale la carica anticorpale derivante dall’avvenuto contagio rendeva non necessaria la vaccinazione. Individuazione che, evidentemente, deve essere compiuta sulla base di dati tecnico-scientifici, che, già di per sé mutevoli nel tempo, lo sono stati tanto più durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, generata da un virus respiratorio, sino ad allora sconosciuto. Ed è proprio in ragione della necessità di adeguare la disciplina in base all’evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite che la norma censurata, anzi che fissare legislativamente il termine in questione, ha ritenuto di demandarne l’individuazione a un atto amministrativo che doveva essere adottato, non a caso, dall’amministrazione istituzionalmente in possesso delle competenze tecnico-scientifiche per farlo”.
Così, l’attendibilità della valutazione tecnico-scientifica che ne è necessariamente alla base determina l’illegittimità della circolare amministrativa, che potrà essere conosciuta dai giudici comuni, cui pure ne è rimessa l’interpretazione, dimostrando, a grandi linee, la tesi dell’integrazione tra diritto e tecnica come riferita ad un diritto giusto, che impone all’amministrazione di conformarsi ai canoni del buon andamento e dell’imparzialità e che guarda alla fattispecie del procedimento amministrativo come all’ideal-tipo al processo di validazione delle conoscenze tecnico-scientifiche. In questo contesto, il collegio consultivo tecnico è chiamato ad operare, laddove il proprio sindacato “arbitrale” sostitutivo della tutela giurisdizionale è chiamato a rapportare la ponderazione degli interessi pubblici e privati al lume del più severo parametro dell’attendibilità tecnico scientifica delle proprie misure decisionali7.
2. Il collegio consultivo tecnico nel nuovo codice dei contratti pubblici alla luce del principio del risultato
In un’organizzazione caratterizzata da forte tecnicità delle strutture amministrative, secondo quanto stabilito dal nuovo codice in merito al principio del risultato e agli altri principi che regolano l’affidamento dei contratti e la scelta del contraente, trova collocazione il collegio consultivo tecnico.
L’art. 215 del codice, con le modifiche di cui all’art. 53 del correttivo, e dell’Allegato V.2 (Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico), sostituito dall’art. 84 del correttivo, in attuazione della legge delega n. 78/2022, individua come un corpo tecnico alternativo alla giurisdizione al fine di “Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti di appalto e di concessione, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato V.٢ è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo ١٧, comma ٣, della legge ٢٣ agosto ١٩٨٨, n. ٤٠٠, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”. Innanzitutto il correttivo al nuovo codice dei contratti pubblici individua nel collegio lo strumento di prevenzione delle controversie, con nuove limitazioni ai costi, confermando la funzione “arbitrale” del collegio, nonché la distinzione tra appalti pubblici e contratti di concessione. Com’è noto, entrambe le tipologie rappresentano contratti sinallagmatici ma si differenziano sia sotto il profilo dell’operazione ad esse sottese che sotto il profilo del pagamento del corrispettivo, nonché sul piano del rischio economico. Risulta abbastanza agevole rilevare, senza riportare le note definizioni di appalto e concessione, come, nell’appalto, il rischio dell’operazione economica vada sopportato dalla stazione appaltante che paga l’appaltatore , mentre in caso di concessione il rischio grava integralmente sul concessionario-imprenditore che “ripaga l’attività svolta sulla base dei flussi di cassa prodotti dall’opera o dal servizio”.8 L’obbligatorietà del parere del CCT e la regolamentazione dei costi sono elementi chiave per garantire il raggiungimento più efficiente del principio del risultato e una sostanziale protezione per i diritti fondamentali delle parti coinvolte. Non solo, ma la stessa “obbligatorietà” della costituzione del collegio per un importo di lavori pubblici così elevato, dovrebbe garantire i funzionari pubblici, preposti alla gestione delle gare pubbliche, dalla c.d. “paura della firma”. Ovviamente sarà la stessa giurisprudenza amministrativa a stabilire presupposti, confini e applicazioni concrete. Le modifiche al collegio Consultivo Tecnico rappresentano, pertanto, un passo avanti verso una gestione maggiormente improntata al buon andamento e all’imparzialità delle controversie negli appalti pubblici. L’obbligatorietà del parere del CCT e la regolamentazione dei costi sono elementi chiave per garantire il raggiungimento più efficiente del principio del risultato e una sostanziale protezione per i diritti fondamentali delle parti coinvolte. Più in generale, il collegio consultivo tecnico nell’ordinamento italiano esprime la transizione delle c.d. disputesboards e rappresenta un passo significativo verso un approccio più orientato al business nella gestione delle opere pubbliche e del risultato, piuttosto che del rispetto della c.d. legalità di forma. Tuttavia, le attuali lacune potrebbero compromettere i benefici potenziali di questo istituto nel prevenire le dispute in materia di contratti pubblici. Il collegio consultivo tecnico svolge anche funzioni consultive, esprimendo pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.
In caso di mancato adempimento alle prescrizioni del parere o delle determinazioni del collegio è valutata dall’amministrazione ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa. La storia normativa del collegio è recente.
Secondo la dottrina, “lo specifico istituto è stato previsto la prima volta dall’art. 207 del d.lgs. n. 50 del 2016 quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla tutela giurisdizionale lasciato alla disponibilità delle parti che potevano convenire la costituzione con funzioni di assistenza per la rapida soluzione e per la prevenzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto”9. L’inquadramento normativo del collegio, fin dalla sua prima istituzione,ha mostrato da subito delle gravi lacune interpretative sull’effettivo ruolo che il collegio avrebbe dovuto svolgere nell’ambito dei contratti pubblici. Ciò al punto che il Consiglio di Stato (parere n. 855/2016) ne aveva auspicato la completa soppressione per l’ incerta collocazione strutturale del collegio come effettivo corpo tecnico di risoluzione delle liti e come istituto simile all’accordo bonario, e quindi, sovrapponibile ad esso, in un ambito di incertezza di rapporti con gli altri rimedi pre-contenziosi già esistenti. L’istituto del collegio ha poi visto una sua completa rivitalizzazione con le c.d.“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, recate, rispettivamente, dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 e dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77. La riformulazione del collegio deriva, in pratica, dal fatto che gli atti di indirizzo politico-governativo derivanti PNRR si ponevano l’obiettivo di prevedere, in via semplificativa, effettivi strumenti di coordinamento e di risoluzione delle controversie in materia di contratti pubblici in sostituzione delle farraginose procedure giurisdizionali10.
La necessità di garantire che gli interventi previsti vengano effettivamente realizzati e che gli obiettivi prefissati siano raggiunti ha posto in primo piano l’importanza del risultato amministrativo nel contesto del delicato equilibrio tra efficienza e legalità dell’amministrazione.
Il legislatore, in particolare,si è concentrato sulla creazione di uno strumentario giuridico complesso, un corpo tecnico capace di risolvere problematiche di tipo processuale e di tipo sostanziale, venendo incontro alle parti contrattuali pubbliche. Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede il collegio dagli artt. 215 al 219, confermando l’attenzione del legislatore verso quest’istituto, le cui potenzialità sono ancora tutte da scoprire. Difatti, l’incertezza dei precedenti interventi normativi fa dell’istituto del collegio un Corpo tecnico a metà tra un tipico strumento alternativo alla tutela il carattere giurisdizionale e una struttura collegiale che, a seconda delle circostanze di fatto o di diritto, assume valenza consultiva, obbligatoria o facoltativa,e, qualche volta, di organo attivo le cui determinazioni, di natura paragiurisdizionale, acquisiscono, in assenza di una specifica volontà contraria, il carattere del lodo contrattuale ex art. 808 c.p.c. Dal punto di vista della natura e delle funzioni, il collegio si connota per lo svolgimento di funzioni paragiurisdizionali alternative a quelle giurisdizionali allo scopo preventivo e risolutivo delle controversie, insorte o potenziali, nel corso dell’esecuzione dei contratti, unitamente alle funzioni consultive, assistenziali per le parti che si esprimono in pareri o determinazioni-lodi contrattuali. L’art. 215 del codice si specifica in due norme precettive, la prima processuale, in cui il collegio è chiamato a risolvere una disputa tecnica relativa a diritti o rapporti giuridici attraverso una pronuncia autoritativa da parte di soggetti a tal fine designati. La seconda nella quale emerge la natura assistenziale del collegio e riflette, nel suo complesso, la finalità d’interesse generale della tempestiva e corretta esecuzione dei contratti con la committenza pubblica. Anche il collegio, in effetti, origina nella peculiare attuazione dei principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2 del codice, ove il secondo è posto in funzione del primo, con rilevanza centrale, in via prospettica, “per gli interventi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC)”11. Il terzo comma dell’art. 215 riveste natura sanzionatoria, nel senso che l’inadempiente sarà colpito dalla sanzione per aver commesso un illecito dove la sanzione serve a soddisfare lo Stato con la refusione monetaria per il danno erariale quanto a soddisfare i sentimenti etici e l’esigenza di ordine diffusi nella collettività.
L’intervento legislativo si è sviluppato sotto tre distinti profili, tutti convergenti verso l’obiettivo unico di assicurare, con un focus sui risultati, l’immediata conclusione dei procedimenti e la stabilità delle decisioni. Il Legislatore, preoccupato di realizzare i principi della fiducia e del risultato, ha ritenuto opportuno implementare gli strumenti alternativi della risoluzione delle controversie risolvendo gli stati di incertezza giuridica relativi alla rimozione del fenomeno dell’amministrazione “difensiva” e della cosiddetta “paura della firma”.
Nella prospettiva del recupero giustiziale della funzione di protezione del buon andamento dell’esecuzione dei contratti viene appunto disciplinato, in maniera fortemente innovativa, l’istituto del collegio, lasciando chiaramente intendere che, nelle intenzioni del legislatore, “ la figura dovrebbe assumere un ruolo assolutamente strategico nell’ambito delle misure di accompagnamento strumentali alla garanzia di realizzazione del PNRR perché destinata ad evitare che dispute o controversie vengano portate e decise in sede giurisdizionale, ritardando o compromettendo il raggiungimento dei risultati programmati”12.
È corretto sottolineare che la peculiarità del collegio rispetto ad altri strumenti di ADR è l’accompagnamento della fase esecutiva, che costituisce il presupposto e il limite temporale della sua operatività. Questo aspetto garantisce un supporto di efficienza e di efficacia nella risoluzione delle controversie e delle dispute, senza percorrere la strada tortuosa delle giurisdizioni. Il modello di riferimento al quale ci si può principalmente ispirare è quello dei Dispute Boards, previsti negli ordinamenti anglosassoni e nei contratti internazionali di appalto di notevole complessità. Questi organi sono nominati dalle parti e svolgono funzioni sia consultive e conciliative che giustiziali.13 Secondo attenta dottrina “ la funzione di questi strumenti può ricondursi in particolare alla prevenzione di comportamenti opportunistici o “autoprotettivi” dei contraenti nei rapporti di durata, quali ad esempio l’iscrizione cumulativa di riserve, suscettibili di erompere in contenziosi in mancanza di immediata soluzione delle cause generative”.14
Il risultato contrattuale è assicurato dal fatto che la situazione descritta, con la “miscela esplosiva” di contenziosi anticipati dalle riserve dell’appaltatore in contabilità, può effettivamente minare lo spirito collaborativo tra le parti sin dalle fasi iniziali dei lavori. “È importante affrontare tempestivamente tali questioni per preservare un clima, tanto più se si considera che gli strumenti tradizionalmente posti per la loro soluzione stragiudiziale non impediscono che, a fine lavori, l’Autorità Giudiziaria sia comunque adita dalle parti, con sostanziale vanificazione di ogni intento deflattivo. In tale quadro poco edificante, invero non dissimile da quello che si riscontra in molti altri ordinamenti europei continentali, la prevenzione del contenzioso, prima che questo possa impattare negativamente sulla regolare ultimazione delle opere, sembra essere una scelta obbligata”15.
Sotto questo profilo, la figura ibrida del collegio lo porta ad essere un punto di equilibrio tra giustizia equitativa-funzioni assistenziali nel comporre la controversia utilizzando le procedure di tipo conciliativo e quindi di accordo tra le parti. Talora con soggezione agli effetti della decisione, talora con libertà di aderire o meno alla proposta conciliativa. Ferme in ogni caso le garanzie di indipendenza, terzietà e professionalità dei membri del collegio.
L’art. 215 del codice è molto chiaro nel delineare le caratteristiche del collegio, pur con le modifiche stabilite nel correttivo che ne fanno un organismo collegiale più vicino alla giurisdizione che all’amministrazione “Ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione”. L’antica disputa tra la giurisdizione e l’amministrazione sembra orientare la natura giuridica del collegio consultivo tecnico verso lo strumento dell’organo paragiurisdizionale.
La caratteristica principale e irrinunciabile del collegio è quella di basarsi sulla volontà delle parti, come tutti gli ADR; volontà che definisce, secondo i casi, con le migliori modalità come gestire una determinata controversia, anche nell’ottica dell’obiettivo e del risultato che si intende perseguire. Da questo punto di vista, lo sguardo del legislatore codicistico non si è basato sulla logica, della disputa, dello scontro, né necessariamente sulla sola applicazione della legge, ma cerca di indagare più a fondo le istanze delle parti, le loro esigenze, gli interessi sottesi al conflitto, il fattore temporale per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione “di risultato” più equo per le parti, ora caratterizzato dall’indipendenza del giudizio e delle valutazioni del collegio stesso. Risulta, quindi, opportuno affermare che il collegio consultivo tecnico è un organo consultivo costituito per garantire la realizzazione dell’interesse pubblico primario nella realizzazione delle opere pubbliche16.
Esso fornisce pareri obbligatori nelle ipotesi di sospensione di cui all’art. 121 del codice dei contratti pubblici. È quindi un organo consultivo costituito per assicurare la realizzazione dell’interesse pubblico primario alla esecuzione dell’opera pubblica e , quindi, il risultato, che rende pareri obbligatori nelle ipotesi di sospensione di cui all’art. 121 del codice e facoltativi in tutti gli altri casi contemplati nell’art. 216 del codice. Più in generale, i pareri del collegio consultivo tecnico possono avere diversi livelli di vincolatività, a seconda dei casi. In alcuni casi, la determinazione del collegio è vincolante e decide direttamente la controversia tra la stazione appaltante e l’operatore economico. In alcuni casi, cioè, decidono, mentre in altri “consigliano” la decisione. Quando l’acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell’insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto.
La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell’ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi del comma 4 dell’articolo 216. Il collegio si presenta, dunque, come un organo consultivo necessario atipico dai compiti misti anche nella sua funzione assistenziale alle parti: rende pareri e adotta determinazioni che , nei casi in cui l’acquisizione del parere non è obbligatorio assume valore di lodo contrattuale ex art. 808 c.p.c.17. Se ci si fermasse a questa sola considerazione, il cumulo di funzioni consultive e decisorie non rappresenterebbe una novità assoluta del sistema ordinamentale, dal momento che l’ordinamento della giustizia amministrativa, o meglio, la nostra Costituzione tollera l’ipotesi che un unico soggetto (a cominciare dal Consiglio di Stato) possa cumulare esercizio di funzione giurisdizionale e consultiva. Attenta dottrina18solleva il problema della compatibilità dell’arbitrato irrituale con la tutela degli interessi pubblici concreti.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione: infatti “non basta richiamarsi alla natura privatistica degli strumenti negoziali adoperati per superare ogni possibile ostacolo all’utilizzabilità dell’arbitrato irrituale nei contratti della pubblica amministrazione. Certamente non v’è alcuna incompatibilità di principio tra la natura pubblica del contraente e la possibilità di un componimento negoziale delle controversie nascenti dal contratto stipulato dalla pubblica amministrazione. Ma resta il fatto che tale componimento, se derivante da un arbitrato irrituale, verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali, appunto) individuati all’interno della medesima logica negoziale, in difetto qualsiasi procedimento legalmente predeterminato e perciò senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità”). In questo senso, si afferma che la pubblica amministrazione non potrà avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati (nella specie, un contratto di affitto agrario), dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero poiché, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie19.
L’istituto del collegio consultivo tecnico è oggi codificato come un rimedio generale pensato per risolvere tempestivamente e in corso di esecuzione del contratto le possibili controversie tra committente e appaltatore, al fine di garantire un’adeguata esecuzione del contratto di appalto nella logica del risultato.
Il che ne autorizza la naturale collocazione nell’alveo delle figure di ADR (Alternative Dispute Resolution) come una forma di dovere di risoluzione efficiente delle controversie pubblicistiche in alternativa alle irragionevoli durate dei processi statali. Ciò si esprime non solo nel carattere meno formale che si svolge innanzi al collegio ma anche nella possibilità per le parti stesse (e in seconda battuta per gli arbitri) di dotare il giudizio dei soli incombenti che appaiono necessari ad assicurare il dovuto e corretto risultato per la parti in causa. Aspetto a questo correlato e in parte conseguente è anche quello della particolare efficienza e celerità che contraddistingue l’ADR. L’istituto dell’ADR collegio consente di realizzare in modo decisamente efficace e più efficiente del processo ordinario quell’esigenza di speditezza che il processo statale sacrifica e sopprime. Con l’apertura dei mercati concorrenziali e con la correlazione tra il sistema giurisdizionale e quello economico la rapida risposta di organi collegiali come il collegio, le ADR et similia costituisce un obiettivo imprescindibile per la sua pienezza ed effettività, poiché più celere è la soluzione di dispute tra committente e appaltatore, quanto più contenuti possono essere i relativi costi o gli effetti distorsivi dei mercati. Da questo punto di vista, il tema della durata dei processi ha caratterizzato la stessa costituzione delle normative comunitarie, prima, ed europee, dopo.
Si tenga presente che proprio l’art. 6 CEDU, che indicava come elemento costituito del processo equo la ragionevole durata del processo, è stato assunto come modello principale per la riforma dell’art. 111 Costituzione, il quale dispone che il processo per essere “giusto” deve essere “regolato dalla legge”, deve svolgersi “nel contraddittorio tra le parti”, “in condizioni di parità” e “davanti ad un giudice terzo”. Appare chiaro, in quest’ambito, che l’efficienza “giurisdizionale” indicata in capo al collegio non è solo l’amministrazione giustiziale che assicura gli elementi fondamentali come la professionalità, l’indipendenza e la responsabilità dei suoi funzionari e la tutela celere della giurisdizione ma è l’organizzazione efficiente ed imparziale contrassegnata, attraverso la realizzazione del risultato amministrativo, da un particolare dovere che si impone all’amministrazione in quanto garante dei diritti fondamentali delle persone, quindi, un corpo tecnico al servizio della società.
In pratica, il collegio – pur ponendosi come obiettivo quello di realizzare un “filtro” in grado di prevenire eventuali successivi contenziosi – svolgendo funzioni tipicamente giustiziali è stato ripensato, rispetto al modello del 2016, con il chiaro intento di “rafforzarne” la funzionalità deflattiva, sottolineando , nel contempo, la pienezza ed effettività della funzione di ausilio e di assistenza per le parti contrattuali.
La ratio del rimedio, infatti, si rinviene nella consapevolezza che – in particolar modo nel settore degli appalti pubblici – esigenze di efficienza e di sviluppo impongono la predisposizione di strumenti idonei a ridurre le negatività derivanti dall’eccessivo contenzioso giurisdizionale, e ciò soprattutto attraverso l’utilizzo di rimedi alternativi di risoluzione e prevenzione delle controversie.20Come si cercherà di argomentare, le previsioni relative al Collegio. presentano particolari novità rispetto ad una “ordinaria” ADR, non solo per il contesto in cui sono destinati ad operare i singoli strumenti, soprattutto per l’aggiunta legislativa di altre funzioni, orientando la gestione conflittuale dell’esecuzione dei contratti pubblici verso la logica del risultato e dell’efficienza.
Nel far riferimento ad esigenze di sistema, il collegio è stato inteso soprattutto come istituto di coordinamento delle varie funzioni codicistiche verso un fine unitario, spesse volte individuato in termini generici come nella vecchia normativa del 2016 ma che nell’attuale normativa21 si specifica nel risultato e nella fiducia. Un mal posto tentativo di sistematizzazione dell’istituto si potrebbe, ad esempio, risolvere nell’individuazione delle sole finalità deflattive delle varie ADR e nella loro attitudine a sostituirsi al processo, ma in realtà, come più volte si è accennato, il collegio, pur nell’inscindibilità e nella reciproca interconnessione tra amministrazione e giurisdizione, è caratterizzato dalla funzionalizzazione dell’attività e dell’organizzazione al raggiungimento dell’obiettivo di massimizzazione delle pretese delle parti contrattuali. Pretese valutate e bilanciate nel procedimento di evidenza pubblica, destinatarie dell’acquisizione di beni e servizi e quindi della tutela ultima dei loro diritti fondamentali. Più in generale, così come descritto nel codice, il collegio si presenta come un corpo tecnico dove l’attività consultiva costituisce, in realtà, non semplice momento di riflessione settoriale, ma strumento suggerito per esaminare, approfondire e valutare la portata e gli effetti del principio del risultato nel codice visto, soprattutto, nella soluzione delle liti22.
Il riferimento al collegio come corpo tecnico tra attività consultiva e giustiziale concentra l’attenzione su profili di carattere generale che hanno contrassegnato negli ultimi trenta anni il sistema amministrativo italiano: semplificazione, capacità decisoria, rapporto fra tecnica e amministrazione e fra tecnica e politica, qualità della burocrazia, rapporto fra tempo e procedimento, fra azione e organizzazione amministrativa, fra legalità ed efficienza23.
Il ruolo codicistico attribuito al collegio nella logica del rapporto tra efficienza e garanzia, sembra, come si è visto, attribuire all’istituto un ruolo proattivo e di promozione della ricerca di efficienza e dei risultati, come valori ed obiettivi che devono tutti essere perseguiti24. Ebbene, è indubbio che la tecnica dal punto di vista oggettivo assuma una decisa rilevanza nella materia dei lavori pubblici. Essa (dovrebbe) sta(re) al di dentro della struttura organizzativa del committente pubblico ma, nel contempo, lo stesso collegio risolve «il ruolo dell’attività consultiva […] nel ruolo degli interessi», così propendendo per la tesi favorevole a riconoscere ai pareri in senso proprio la connotazione di «strumento» per l’introduzione di interessi nel procedimento che poi condurranno al risultato amministrativo25. La ratio di fondo dell’istituto del collegio è in ultimo la scelta di giungere alla definizione dell’interesse pubblico da perseguire in concreto nei contratti pubblici non già come applicazione solitaria della legge ma come ampio e continuativo confronto con altri interessi pubblici e privati in gioco affidato in esclusiva alla decisione del citato corpo tecnico-professionale.
La considerazione dell’adeguatezza del collegio rispetto agli interessi delle parti è confermata dalle attuali disposizioni del codice, che si differenziano dalla normativa precedente per aver introdotto una serie di principi, come quello del risultato, della fiducia e di accesso al mercato, che mirano a guidare anche le c.d. funzionalità degli istituti deputati alla governance dei contratti pubblici. Come già anticipato, si reputa che proprio questi principi posti in evidenza dal nuovo codice possano ridefinire l’ambito entro il quale si situano le ADR e, in particolar modo il collegio, e la rilevanza che tali strumenti assumono nel sistema amministrativo generale e, qualche, “giurisdizionalizzato” al risultato.
Il principio del risultato, definito dal legislatore codicistico come derivante dai principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, è di particolare rilevanza. Applicato al contesto contrattuale, questo principio si traduce in un criterio direttivo volto ad accelerare sia la buona conclusione dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei contratti. Nei contratti pubblici il risultato amministrativo deve essere ricercato nel collegio come elemento derivante dalla combinazione della razionalità del procedimento e della proporzionalità delle determinazioni di soluzione preventiva o successiva delle dispute. Il principio del risultato espande le proprie latitudini fino alla gestione delle controversie correlate allo svolgimento della gara ed all’esecuzione del contratto così da garantire che la c.d. res litigiosa si concluda in tempi brevi da non ostacolare la realizzazione delle opere o l’adempimento delle prestazioni attese . In buona sostanza, il ricorso al collegio si riconduce alla prospettiva della contrattualità di risultato e trova quindi una ragion d’essere in rapporto alla sua capacità di comporre le liti in termini tali da garantire la sollecita attuazione delle scelte programmatiche dell’amministrazione.
Questa riflessione incide sulle modalità di scelta della “conclusione” sulle controversie, o prevenirle o chiuderle, nella parte in cui svela quali siano gli interessi in gioco e con quali modalità si formi la decisione di utilizzare il collegio, anziché promuovere l’opzione giurisdizionale.
Nel collegio, l’effettivo adempimento delle prestazioni concordate è di fondamentale importanza in base ai bandi e agli altri disciplina di gara e la tempestività dell’adempimento garantisce la copertura dei costi dell’attività, i quali possono essere condizionati dall’insorgere di conflitti.
In particolare, l principio di fiducia emerge come uno dei superprincipi del nuovo codice, accanto al principio del risultato. In varie forme, la fiducia e il risultato promuovono la collaborazione tra le parti del contratto in ogni fase della sua esecuzione, compresa quella in cui possono sorgere controversie riguardanti l’adempimento delle singole obbligazioni. Le relazioni collaborative necessariamente scaturenti dall’osservanza dei due principi suddetti comportano, pertanto, una preferenza per una celere “transazione” della disputa in luogo dell’esercizio del diritto di azione processuale. Secondo la dottrina “Se si assume che i principi di risultato e fiducia orientino le parti verso una composizione stragiudiziale delle liti, resta da chiarire su quali basi si fondi l’assunto per cui le ADR sarebbero più adeguate del processo a garantire l’attuazione del programma negoziale. Il discorso si deve concentrare sulle caratteristiche delle controversie, tenendo conto delle peculiarità del riparto di giurisdizioni e dei costi che esso determina, oltre che dei limiti della cognizione giudiziale dei diritti ed obblighi delle parti in conflitto.
Se si tralasciano le peculiarità del parere precontenzioso, il legislatore ha introdotto un’articolata serie di rimedi stragiudiziali al fine di evitare che le parti siano esposte alle incertezze derivanti dalle prassi interpretative in materia di riparto o siano gestite con tecniche e strumenti propri del rito civile.
Per quanto concerne i costi del riparto, è appena il caso di osservare come la disciplina della translatio iudicii possa compensare i rischi derivanti dall’errata scelta dal giudice, ma non i costi nascenti dalla dilatazione dei tempi processuali e dalla cassazione delle sentenze viziate dal difetto di giurisdizione”26.
I principi di risultato e della fiducia si riconnettono anche nella fase complessa dell’esecuzione dei contratti. L’interazione fra diritto comune e diritto speciale può rendere può rendere complessa la soluzione della controversia tra committente pubblico e operatore giuridico privato dove i problemi relativi alla sospensione dei lavori, alla variazione dei prezzi. Soluzione che deve essere presa per il più celere raggiungimento del risultato, inteso come dovere giuridico di realizzazione. Il fenomeno dell’equità sostitutiva può essere allora considerato dal collegio come una scelta di risultato immediato con rinvio alla formula contenuta nell’art. 822 c.p.c. che così recita “Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità.
Non mi sembra di scorgere nel nuovo codice divieti di esprimersi secondo equità. Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili..
Non mi sembra di scorgere nel nuovo codice divieti di esprimersi secondo equità nella soluzione di problemi tecnici o giuridici, purché si tenga presente l’obbligo di realizzare il risultato amministrativo. Nell’art. 822c.p.c. la formula impiegata “con qualsiasi espressione” è volutamente ampia e in tal senso viene giustamente interpretata da dottrina e giurisprudenza. Tra le espressioni più frequentemente utilizzate vi è l’autorizzazione agli arbitri a giudicare in via equitativa o “come amichevoli compositori”ovvero “ex bono et aequo”. In questi casi, dunque, i componenti il collegio scelgono regole discrezionali, non identificabili prima del processo o al di fuori del suo ambito.
Anche nel giudizio di equità non viene meno per gli arbitri il rispetto dei superiori principi di ordine pubblico e le norme giuridiche imperative il cui rispetto è imposto dall’ordinamento di riferimento. Si discute se il collegio, invece dell’equità decida secondo diritto. Secondo alcuni autori si avrebbe una violazione della regola della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e dunque il lodo sarebbe da considerare invalido. Secondo altri, invece,la decisione potrebbe comunque risultare valida,in quanto il giudizio di equità attribuirebbe al collegio un potere nella sostanza maggiore tale “da attribuirgli pertanto anche la possibilità di decidere secondo diritto, considerando l’applicazione delle norme di legge come la soluzione comunque più opportuna e dunque conforme all’equità”27.
Una tale concezione deriva dal fatto che il principio del risultato costituisce il criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto. Tutto questo non esime il committente pubblico e l’operatore economico dallo scegliere la soluzione più celere, tempestiva ed opportuna per la soluzione della controversia stragiudiziale innanzi al collegio.
Che il ricorso al collegio postuli rapporti fiduciari fra le parti, quale base per una effettiva negoziazione degli interessi in conflitto, è dato di partenza messo bene in luce dalla dottrina che più si è occupata delle premesse metodologiche del ricorso a tali tecniche. In una prospettiva teorico generale28.
Le parti possono sempre orientarsi nella scelta del collegio, tenuto conto di loro specifiche esigenze, della particolare complessità della controversia o della riscontrata necessità di avere a disposizione un esperto professionista particolarmente attento e dotato di specifiche conoscenze tecniche nel settore dei contratti pubblici.
La costituzione del collegio, sotto questo profilo, diventa un elemento tale da rafforzare quella particolare fiducia nell’organo giudicante che, in ultima analisi, non potrà che giovare allo svolgimento del procedimento alla realizzazione celere e fattiva del risultato atteso. In questo senso, parlando, appunto di ADR pubblici non è da escludere una rinnovata attenzione per il rapporto fra tecnica e semplificazione, ma anche quello fra tecnica e politica. “Da un lato, infatti, la prima tende a perdere il carattere di valutazione istituzionale, nel senso di valutazione posta in essere da organismi istituzionali, per essere talvolta affiancata da quella di soggetti tecnici legati da un rapporto fiduciario con il vertice politico; dall’altra, l’intervento di soggetti tecnici ha qualche volta assunto, soprattutto a livello dei decisori regionali e locali, il valore di strumento di attuazione di scelte politiche.”29
La disciplina normativa sul collegio sembra che stia mutando il contesto entro cui valutare i rapporti fra giudice ed amministrazione, ma permangono le riserve sui rapporti fra amministrazione e giurisdizione. ll diritto ad una tutela giudiziale effettiva, ivi compresa l’attività consultiva esercitata dal collegio non deve entrare in conflitto con le esigenze di un’efficiente allocazione delle risorse pubbliche, compromettendo il buon andamento dell’amministrazione, così ostacolando la rapida attuazione delle politiche pubbliche nella logica del risultato. A tal proposito, non possono escludersi le tensioni tra il tempo del processo, che viene abbreviato in materia di pubblici appalti, e il tempo dell’azione amministrativa, che dovrebbe assicurare una soluzione immediata ai vari problemi che emergono dalle prassi attraverso i copri tecnici giustiziali come il collegio. Quest’ultimo, nato come strumento per ridurre il contenzioso, può rappresentare un punto di equilibrio tra la protezione del committente pubblico, gli operatori economici e le responsabilità dell’amministrazione nel rendere conto delle proprie azioni alla collettività.
Nella vigente disciplina il principale incentivo concerne il descritto regime di responsabilità attenuata dei funzionari che decidono di utilizzare il collegio. Si tenta, così,“di superare il modello della burocrazia difensiva, propensa ad attendere la sentenza del giudice anziché ad assumere i rischi di una diversa soluzione della lite. Questo incentivo rischia, tuttavia, di veicolare una concezione strumentale delle ADR, intese come alternativa deresponsabilizzante rispetto all’alea processuale ed alle conseguenze derivanti da possibili danni erariali30. Il principio del risultato dovrebbe guidare non solo l’amministrazione attiva, ma anche le Alternative Dispute Resolution (ADR) come rimedi a disposizione delle parti coinvolte. In questo contesto, sia le decisioni giurisdizionali che le funzioni consultive del collegio devono rispettare, oltre ai principi giuridici come misura di legalità amministrativa anche le misure di merito e, quindi, l’opportunità di procedere a verificare eventuali ritardi e/o inadempimenti, silenzi delle parti nell’esecuzione dei contratti.
Se, come sopra detto, il potere amministrativo non può dirsi assoluto e il principio del risultato e della fiducia sono frutto di costanti correzioni. Il rimedio dell’ADR pubblica come il collegio diventa uno strumento importante di risoluzione delle controversie, sempreché si tenga conto del principio della fiducia nell’ottica della garanzia di terzietà e di specializzazione degli organi competenti.
3. Considerazioni conclusive
Qualche riflessione di sintesi. Negli ultimi tempi, come si è visto, il tema dei rapporti tra tecnica e diritto è tornato alla ribalta. Esso è stato oggetto di numerosi studi, che potrebbero essere interpretati come un profondo “disagio” del mondo dei giuristi nei confronti di un fenomeno, quello della c.d. “tecnica”, difficilmente inquadrabile negli schemi tradizionali della teoria generale del diritto. Nei diversi scritti della dottrina amministrativistica affiora la tendenza a scegliere come terreno privilegiato di osservazione i principi di ragionevolezza e di proporzionalità31. Il dato è gravido di implicazioni sul versante ricostruttivo, dal momento che suggerisce l’idea che tali principi, con le loro pratiche del bilanciamento, possano costituire una possibile soluzione ad una migliore compenetrazione e afferenza tra diritto e tecnica. Il tutto nell’ottica dell’effettività del principio del risultato nel settore dei contratti pubblici.
Nulla vieta, quindi, che il collegio assuma, ancor di più, nel tempo, e le prassi ce lo diranno, le sembianza di un corpo tecnico indipendente, separato dagli organi di amministrazione attiva, oppure organi speciali di amministrazione giustiziale per specifici settori di amministrazione, andando ad arricchire il catalogo degli strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento, posti tra il processo e il procedimento. Ciò “all’insegna di una idonea adeguatezza e specificità nella risposta di giustizia, nonché di una certa fairness, intesa come leale collaborazione, tra le parti”, per la piena attuazione delle prerogative fondamentali della persona umana32.
_______
(1) F. Francario, Il Collegio consultivo tecnico. Misura di semplificazione e di efficienza o inutile aggravamento amministrativo? in Dir. e Processo amm. 15 luglio 2022; P. De Bernardinis, Commento artt. 215-219, Libro V in R. Giovagnoli, G. Rovelli ( a cura di), Codice dei contratti pubblici, Milano Giuffrè, 2024, p. 1914.
(2) In merito ai principi della tecnica e ai principi generali, si veda P. Perlingieri, P. Femia, Realtà sociale e ordinamento giuridico in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 11 edizione aggiornata ed integrata con indicazioni giuripsrudenziali, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2022, p. 18 e ss.
(3) A. Moliterni, Il sindacato giudiziario sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione (tra mito e realtà) in M. Trimarchi, Concetti giuridici indeterminati e standards valutativi del potere amministrativo, Diritto e Processo.Quaderni,43,Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 140 e ss.
(4) ID. op. ult. cit., p. 142. Sull’impoverimento di forza del diritto dinanzi alla potenza della tecnica che però non riesce a minare l’autonomia della normatività giuridica, N.Irti, E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, Laterza, 2001, passim e L. Mengoni, Diritto e tecnica in Riv.trim.proc.civ., n.1/2001, pp. 6 e ss. il quale afferma come “ la validità di una legge era subordinata non solo all’essere stata posta in conformità di regole di competenza e di procedura, ma anche alla conduzione di riducibilità logica del suo contenuto alle strutture concettuali del sistema normativo, e quindi, per questa via, alla fondabilità in un nucleo di principi morali sottesi ai concetti formali posti al vertice del sistema”. Sul punto, J.Habermas, Fatti e norme, Bari-Roma, 2013, p. 483; A.Falzea, Gli standards valutativi e la loro applicazione, ora in ID., Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, I, Teoria generale del diritto, Milano Giuffrè, 1999, pp. 369 e ss.
(5) A. Moliterni, Il sindacato giudiziario sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione (tra mito e realtà), cit., p. 140; B.Marchetti, D. De Pretis, “La discrezionalità della pubblica amministrazione” in G. della Cananea, M. Dugato (a cura di), Diritto amministrativo e Corte costituzionale, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2006, pp. 341-385; G. Parodi, Tecnica, ragione e logica nella giurisprudenza amministrativa, Torino, Giappichelli, 1990, p. 176.
(6) Corte cost., 27 luglio 2023, n. 171 in Giur.cost., 2023, 4, p. 1756. Riguardo alla necessaria motivazione dei profili di violazione del parametro, in maniera non generica, né inconferente, cfr. i richiami contenuti nelle Corte cost., 20 luglio 2023, n.156 in Foro it. 2023, 11, I, pp. 2976; Corte cost., 23 febbraio 2023, n. 28 in Giur.cost., 1, pp. 281 e ss.
(7) Sulla prospettiva ragionevole della costruzione della discrezionalità amministrativa, su tutti, A. Zito, Teoria della scelta razionale e della scelta giuridica della discrezionalità amministrativa: prolegomeni per un inquadramento sistematico, in Nuove Autonomie, 2002, pp. 88 e ss.
(8) R. Ursi, Diritto amministrativo generale, Milano, Volters Kluver, 2024, p. 485. Sulle modifiche del Codice dei contratti pubblici ad opera del correttivo, S. Anzani, Collegio consultivo tecnico (CCT): cosa cambia dopo il correttivo al Codice Appalti in Rass. Giur.quotidiana del 18.11.2024, pp. 1 e ss.
(9) Cfr. I. Lagrotta Commento all’art. 215 in L. R. Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pubblici commentato. d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, cit., p. 1706.
(10) Più in generale sulle politiche pubbliche del PNRR e, quindi, sul PNRR come fonte peculiare nel quadro della disciplina della contrattualistica pubblica, si veda l’ottimo lavoro di E. D’Alterio, Riforme e nodi della contrattualistica pubblica in Dir. amm., n. 3/2022, p. 667 ss.
(11) L. Caruccio, Commento all’art. 215 in R.Villata-M.Ramajoli, Commentario al Codice dei contratti pubblici, cit., p. 1002.
(12) F. Francario, Il Collegio consultivo tecnico, organismo atipico di mediazione e di conciliazione in ambito pubblicistico in Dir. e proc. amm del 30 novembre 2023, pp. 1 e ss.
(13) C. Costanzi, Dal disputeboard al collegio consultivo tecnico. profili comparatistici, diacronici e critici della semplificazione “all’italiana” in Riv. Giur. Ambiente Diritto.it n 2/2021, p. 1; Cfr., ex multis, M. Nunziata, Il disputeboard nei contratti di appalto internazionali. Prospettive di prevenzione e di risoluzione delle controversie, Torino, Giappichelli, 2021, passim.
(14) L. R. Perfetti, Derogare non è semplificare. Riflessioni sulle norme introdotte dai decreti semplificazioni ed in ragione del PNRR nella disciplina dei contratti pubblici, in Urb. e appalti, 4, 2022, p. 441 ss.
(15) Cfr. C. Costanzi, Dal dispute board al collegio consultivo tecnico. profili comparatistici, diacronici e critici della semplificazione “all’italiana”, cit. p. 7. Sul dispute boards, si vedano le opere di ; C. Vaccà, L’arbitrato negli appalti pubblici, privati, internazionali, Milano, 2007, p. 233; N. G. Bunni, The FIDIC, Forms of Contract, Oxford, 2005. G. Owen, B. Totterdill, Dispute Boards: Procedures and Practice, London, 2007, spec. p. 100; P. H. J. Chapman, Dispute boards on major infrastructureprojects, in Management, Procurement and Law; 2009, pp.7 ss.; C. Chern, Dispute Boards: Practice and Procedure, London, 2015; C. Chern, The Law of Construction Disputes, London, 2010.
(16) F. Francario, Il Collegio consultivo tecnico, organismo atipico di mediazione e di conciliazione in ambito pubblicistico in cit., p. 1 e ss.
(17) È da rilevare che secondo parte della dottrina, F. Danovi, L’arbitrato. Una giurisdizione su misura, Milano Giuffrè, 2020, 310, con l’avallo giurisprudenziale, la particolare qualità del giudizio esercitato dagli arbitri consente un deciso accostamento a quello del giudice ordinario proprio perché l’attività degli arbitri può rientrare a pieno titolo nella nozione di giurisdizione. In questo senso si è espressa la fondamentale Cass. civ sez. un., 6 luglio 2016, n.13722 in Riv. dell’Arbitrato 2017, 3, 549 (nota di Debernardi secondo la quale “Non può omettersi di rilevare, sempre in via generale, che le Sezioni unite ord.di questa Corte (Cass., 25 ottobre 2013, n. 24153 in Foro it.,2013, 12, 3407) hanno di recente riaffermato la natura giudiziale dell’arbitrato rituale, ponendo in evidenza, per quanto in questa sede maggiormente rileva, che “anche per ciò che riguarda la prescrizione, il novum è dato non tanto dalla espressa previsione che la prescrizione è interrotta dall’atto introduttivo del giudizio arbitrale (in base all’emendamento portato all’art. 2943 c.c.), quanto dalla attribuzione (testo novellato dell’art. 2945 c.c., u.c.), alla notifica dell’atto di promovimento del giudizio arbitrale, dell’effetto interruttivo-sospensivo (o di interruzione permanente fino all’acquisto di stabilità del lodo, o al passaggio in giudicato formale della sentenza resa sull’impugnazione) che è proprio soltanto della domanda giudiziale, e che integra un tipico effetto sostanziale dell’atto di esercizio dell’azione giudiziaria, “neutralizzando” l’incidenza della durata del procedimento di cognizione, che si conclude con pronuncia di merito (favorevole o meno all’attore) ai fini del decorso del termine prescrizionale del diritto azionato. Soltanto il riconoscimento della “giurisdizionalità” del processo arbitrale consente di estendere l’effetto interruttivo della domanda al termine di decadenza, anche in quella vasta area di fattispecie in cui la decadenza è impedita non con il semplice esercizio del diritto, ma con l’esercizio dell’azione in giudizio”.
(18) F. Francario, Il Collegio consultivo tecnico, organismo atipico di mediazione e di conciliazione in ambito pubblicistico, cit., pp. 1 e ss. che pone il problema della presunta incompatibilità di principio tra la natura pubblica del contraente e la possibilità di un componimento negoziale delle controversie nascenti dal contratto stipulato dalla pubblica amministrazione; id., La natura giuridica delle determinazioni del collegio consultivo e tecnico,in L’amministrativista, 2021, p. 1 ss.
(19) Cass. civ., sez. III, ord., 8 aprile 2020, n. 7759 (rv. 657509-01) in Cassazione Ced, 2020.
(20) M. Calabrò, L’evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle appropriate dispute resolution in www.federalismi.it n. 10/2017, p. 12 e ss.; F. Aperio Bella, Il nuovo parere precontenzioso vincolante ANAC: la tutela giustiziale nei confronti della pubblica amministrazione tra procedimento e processo, in www.rivistaaic.it, 4/2016, p.22; R. De Nictolis, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 2016, p. 537; E. Follieri, Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 8-9/2016, p.895. Sul punto anche F. Giosis, Il Collegio consultivo tecnico e la sua veste arbitrale: profili sostanziali e di tutela giurisdizionale in Diritto e Processo amministrativo, 21 marzo 2024, p. 1 ss.
(21) D. Vese, L’efficienza dell’organizzazione amministrativa come massimizzazione dei diritti fondamentali, cit., p. 279 e ss.; Per una ricostruzione dei rapporti tra ADR, principio del risultato e della fiducia, si veda l’ottimo lavoro di A. Cassatella, I rimedi alternativi alla giurisdizione nell’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni in Dir.amm., n. 4/2023, p. 799 ss. il quale sostiene che “Questa funzionalizzazione avrebbe, infatti, un valore più nominale che operativo, risultando inadatta a cogliere le peculiarità delle singole tecniche ed i loro rapporti . Ragionare in termini sistematici impone, semmai, di stabilire le ragioni della concorrenza fra tecniche di tutela stragiudiziale e giudiziale, al fine di approfondire le caratteristiche dei singoli strumenti e le loro possibili relazioni. Questo punto di vista consiglia, innanzitutto, di tornare a riflettere sulla stessa nozione di ADR e sul significato da attribuire allo stesso concetto di “alternativa” alla giurisdizione, specie tenendo conto della centralità che le tutele giudiziali assumono negli ordinamenti europei . A questo riguardo, si reputa che la stessa tassonomia di ADR, ripresa da lingua e cultura anglosassoni, meriti di essere rettificata, perché pare inidonea a cogliere i tratti più caratteristici dell’attuale fenomeno. Non è infatti sufficiente soffermarsi sul fatto che queste tecniche siano alternative alla giurisdizione, ma occorre stabilire quanto siano appropriate agli interessi delle parti”.
(22) Tra i precursori dell’evoluzione dei corpi tecnici nell’amministrazione si veda, A. Sandulli, Quali riforme per la pubblica amministrazione?, in Munus, 2019, p.VI, ha indicato proprio la necessità di «ricostruire i corpi tecnici delle pubbliche amministrazioni», ricordando che «tra fine Ottocento e primi del Novecento si era investito fortemente sui corpi tecnici: genio civile, sovrintendenze, ispettorati. I migliori ingegneri, architetti, storici dell’arte, lavoravano per le amministrazioni”. Sulle burocrazie “professionali” Cfr. A. Varni, G. Melis (a cura di), Burocrazie non burocratiche. Il lavoro dei tecnici nelle amministrazioni tra Otto e Novecento, Torino,Rosenberg & Sellier, 1999.
(23) A. Pajno, Legge n. 241/1990, corpi tecnici e attività consultiva in A. Bartolini, T. Bonetti, B. Marchetti, B.G. Mattarella, M. Ramajoli ( a cura di), La legge n. 241 del 1990, trent’anni dopo, Torino, Giappichelli, 2021, p. 259 e ss.
(24) Cfr. L. Fiorentino, I corpi tecnici nelle amministrazioni: problemi attuali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, p. 479 ss. Importante il rilievo di S. Cassese, Il sistema amministrativo italiano, Roma, 1982, p. 139, il quale osserva come «[i]n un sistema amministrativo razionalmente organizzato strutture, personale, finanza e procedure sono “funzioni delle funzioni”. Ciò significa che – al variare degli obiettivi della pubblica amministrazione – variano in misura proporzionale, le altre parti».cfr. F. Merloni, Interesse pubblico, funzioni amministrative e funzionari alla luce del principio di distinzione tra politica e amministrazione, in A. Contieri, F. Francario, M. Immordino, A. Zito (a cura di), L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, I, Napoli Editoriale Scientifica 2010, p. 3 ss., spec. p. 46; G. Alpa, Dal diritto pubblico al diritto privato, I, Modena, 2017, p. 12.
(25) Sul parere come manifestazione di interessi nel procedimento si veda, C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, Bologna, Il Mulino 2002, pp. 33-35; C. Videtta, L’amministrazione della tecnica. La tecnica tra procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2008, p. 181 ss.; M.Cammelli, Corpi tecnici e legge n. 241: un contributo per le ricerche in A. Bartolini, T. Bonetti, B. Marchetti, B.G. Mattarella, M. Ramajoli (a cura di), La legge n. 241 del 1990, trent’anni dopo, cit., p. 330 e ss.; E. Guarnieri, L’attività consultiva nel bilanciamento tra tecnica e semplificazione in A. Bartolini, T. Bonetti, B. Marchetti, B.G. Mattarella, M. Ramajoli (a cura di), La legge n. 241 del 1990, trent’anni dopo, cit., p. 207 e ss.
(26) A. Cassatella, I rimedi alternativi alla giurisdizione nell’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni, cit., pp. 799 e ss.
(27) F. Danovi, L’arbitrato. Una giurisdizione su misura, cit., p. 325.
(28) Sulla compatibilità dei modelli di soluzione del conflitto con i valori costituzionali si vedano, S. Dalla Bontà, Mediation: A Sleeping Beauty. La promessa della giustizia consensuale alla luce della riforma della giustizia civile, in Giustizia Consensuale, 2023, 1, specie, pp. 265 ss.; cfr. A. Simoncini, E. Cremona, Mediazione e Costituzione, sempre in Giustizia consensuale, 2022, 3 ss; P. Lucarelli, Mediazione dei conflitti: una spinta generosa al cambiamento, in Giustizia consensuale, 2021, 1, p. 15 ss.
(29) A. Pajno, Legge n. 241/1990, corpi tecnici e attività consultiva, in A. Bartolini, T. Bonetti, B. Marchetti, In B.g. Mattarella, M. Ramajoli (a cura di), La legge n. 241 del 1990, trent’anni dopo, cit., p. 259 ss.
(30) A. Cassatella, I rimedi alternativi alla giurisdizione nell’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni, cit. p.808. Interessanti e complete sono le riflessioni in materia di rapporti tra tecnica e principio di proporzionalità, di V. Fanti, Il sindacato giudiziario sulle scelte discrezionali attraverso la proporzionalità in Concetti giuridici indeterminati e standards valutativi del potere amministrativo,cit., p. 119 e ss.
(31) G. Corso, Osservazioni sulle relazioni di Marcello Clarich e Margherita Ramajoli in M. Trimarchi (a cura di), Concetti giuridici indeterminati standards valutativi del potere amministrativo, cit., p. 43, dove si afferma che “i concetti giuridici indeterminati sono concetti empirici, che designano una situazione di fatto, talvolta apprezzabile in base a nozioni della scienza e della tecnica, ovvero designano un valore, rinviando a parametri di tipo etico o alla c.d. coscienza sociale (ad es. il buon costume).
(32) “Alcuni processi di trasformazione in atto impongono di rivedere la tradizionale posizione di chiusura che configura una sorta di incompatibilità ontologica tra forme di ADR e controversie in cui venga in rilievo l’esercizio del potere amministrativo. In particolare, la concezione della giurisdizione come risorsa pubblica limitata e l’idea che l’interesse pubblico concreto possa racchiudere al suo interno anche il superamento del contenzioso portano a interrogarsi sui possibili spazi di applicabilità di metodi alternativi di risoluzione delle controversie pubblicistiche”. In questo senso M. Ramajoli, Interesse generale e rimedi alternativi pubblicistici in Dir.proc.amm., 2/2015, p. 496, che conclude sostenendo che: “In questa maniera si rimane sempre nell’ottica delle ADR precontenziose, attribuite a soggetti estranei al circuito giudiziario. Ma nulla vieta neppure di attribuire anche a un giudice, a processo già instaurato, il compito di conciliare le parti, prospettando possibili soluzioni riversabili in un accordo oppure idonee a modificare o eliminare parzialmente uno o più provvedimenti amministrativi impugnati. Questo modello di ADR impone logicamente di separare la fase conciliatoria da quella decisoria, affidando il tentativo di mediazione, nel corso del quale i contendenti possono ridefinire la loro relazione, eventualmente grazie a concessioni reciproche, a un giudice esterno al collegio giudicante e adeguatamente formato e sensibilizzato alla cultura della mediazione”.
- Canali tematici
- Contenuti
- Channel
- Il Quotidiano
- Massimario
- Codice appalti commentato
- Prodotti Maggioli















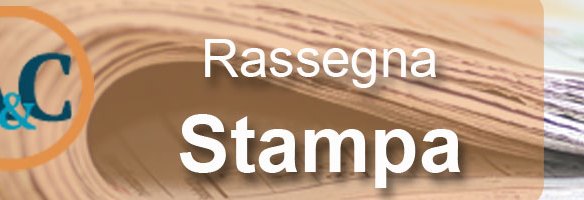
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento